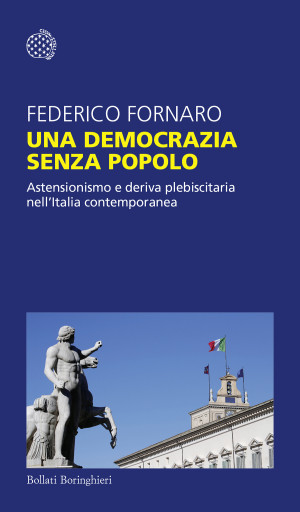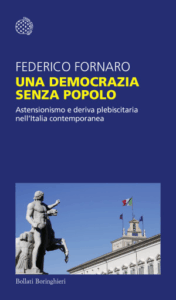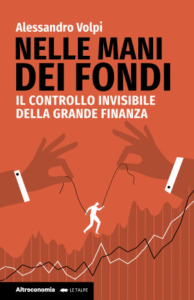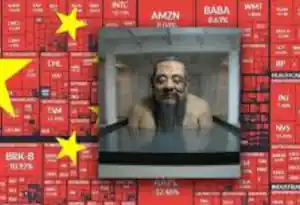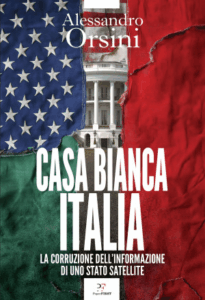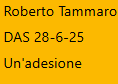Ordoliberalismo e Miracolo Tedesco: L’Europa alla Svolta? – di Gian Luigi Betti
Dalla ricostruzione postbellica alla crisi attuale, il modello ordoliberale tedesco ha plasmato l’economia europea. Ma con l’abbandono del welfare a favore del warfare, la Germania rischia di trascinare l’UE verso un declino irreversibile. Tra austerità, guerre energetiche e subalternità agli USA, l’Europa è a un bivio: riarmo o collasso?
Abstract
L’articolo analizza il ruolo dell’ordoliberalismo tedesco – incarnato dall’economia sociale di mercato – nella ricostruzione post-1945 e nell’integrazione europea. La Germania Ovest, grazie a un modello equilibrato tra libertà economica, welfare e codeterminazione, divenne il motore continentale, influenzando i parametri di Maastricht e l’austerità imposta all’Eurozona.
Oggi, però, shock globali (crisi finanziarie, pandemia, guerra in Ucraina) minano questo sistema. La rottura con la Russia ha destabilizzato il business model tedesco basato su energia a basso costo ed export, spingendo Berlino verso un liberismo militarizzato (warfare). Intanto, l’UE – dominata dal blocco Germania-Paesi frugali – amplia le disuguaglianze: welfare generoso per il Nord, austerity per il Sud (Grecia, Italia).
La conclusione è drammatica: l’ordoliberalismo, già in crisi, cede il passo a un’Europa sempre più subalterna agli USA, dove la spesa sociale viene sacrificata per il riarmo. Senza una riforma radicale, l’alternativa è tra un’Europa prussiana iper-militarizzata e il collasso definitivo del progetto comunitario.
Parole chiave: Ordoliberalismo, Economia sociale di mercato, Austerità, Guerra in Ucraina, Guerra economica, Subalternità agli USA.
Premessa
La ricostruzione economica del secondo dopoguerra ha rappresentato uno dei passaggi più straordinari della storia contemporanea. In particolare, paesi come l’Italia, il Giappone e la Germania Ovest hanno conosciuto una fase di rapida modernizzazione e crescita che ha trasformato radicalmente le loro economie. In un precedente lavoro si è evidenziato come Italia e Giappone abbiano seguito modelli di economia mista, sostenuti rispettivamente – il primo dal Piano Marshall – ed il secondo dal governatorato americano in Giappone. La Germania Ovest, pur beneficiando anch’essa degli aiuti dell’ERP, imboccò una strada differente: l’economia sociale di mercato (Soziale Marktwirtschaft), ispirata ai principi ordoliberali della Scuola di Friburgo (Walter Eucken, anni 1930). Questo modello, contrapposto al liberismo della Scuola di Chicago (Milton Friedman, 1950-1970), avrebbe plasmato l’architettura economica europea.
Gli shock globali e i mutamenti “epocali” che stiamo vivendo in questi anni stanno mettendo a dura prova il modello ordoliberale applicato alla governance dell’Unione europea. Si sta passando da un sistema che garantisce un buon welfare per un ristretto numero di paesi ad un modello orientato al warfare che difficilmente potrà garantire un redistribuzione sociale di parte dei profitti realizzati dal sistema industriale finanziario.La domanda è inevitabile: fine dell’ordoliberalismo significa fine dell’Europa?
La Germania della ricostruzione
Alla fine della Guerra, nel 1945 la Germania era devastata, forse ancor più del Giappone: città distrutte, produzione crollata di oltre il 50%, milioni di profughi interni, una perdita demografica (e produttiva) pari ad una intera generazione di caduti in guerra (5,6 milioni). La divisione del paese tra il blocco sovietico e quello occidentale rese urgente una ricostruzione anche in funzione strategica. Gli aiuti del Piano Marshall (ERP) garantirono risorse materiali e supporto politico. Un passaggio cruciale fu la riforma monetaria del 1948, con l’introduzione del Marco tedesco: misura che mise fine all’iperinflazione e diede slancio alla fiducia nel sistema economico.
Il modello dell’economia sociale di mercato
La Germania Ovest adottò un modello noto come Soziale Marktwirtschaft, concettualizzato da Ludwig Erhard che operò ininterrottamente con diversi incarichi governativi di primo piano negli anni 1948-1966.
. Si trattava di una “terza via” tra liberismo puro e dirigismo statalista. I punti salienti:
• Libertà di mercato regolata con norme antitrust per garantire concorrenza;
• Stato regolatore, (non imprenditore), ma attivo nel welfare e stabilità macroeconomica;
• Sostegno strategico a settori chiave (acciaio, auto, chimica);
• Welfare universalistico (pensioni, sanità, sussidi di disoccupazione);
• Codeterminazione (Mitbestimmung), con rappresentanza dei lavoratori nei consigli aziendali.
Il successo fu eclatante: tra il 1950 e il 1960, il PIL crebbe del 7% annuo, grazie a manodopera qualificata (inclusi milioni di immigrati da Italia, Spagna e Turchia), investimenti tecnologici e politica valutaria favorevole alle esportazioni. Ludwig Erhard, il principale artefice di questo modello, coniò l’espressione “benessere per tutti”.
Confronto con Italia e Giappone
Se confrontiamo i tre modelli del dopoguerra:
• Italia puntò su un’economia mista con forte presenza pubblica (IRI, ENI), ma con squilibri territoriali (Nord/Sud) e clientelismo.
• Giappone seguì un capitalismo coordinato: lo Stato guidava i grandi conglomerati (keiretsu) tramite ministeri come il MITI (che coordinava tutti i ministeri economici).
• Germania mantenne un equilibrio tra mercato e regole, con welfare e disciplina fiscale.
Tutti e tre i modelli dimostrarono l’efficacia di un ruolo attivo dello Stato, seppure con approcci divergenti.
Le crisi dell’ordoliberalismo
Il modello entra in difficoltà per tre fattori principali:
1. Crisi finanziaria (2008-2013): l’austerità imposta all’Eurozona aggravò le recessioni nei Paesi periferici;
2. Pandemia e crisi energetiche (2020-oggi): l’emergenza costrinse a derogare al rigore fiscale;
3. Guerra in Ucraina: la rottura con la Russia ha compromesso il modello tedesco, basato su energia a basso costo ed export verso Est.
L’attuale cancelliere Friedrich Merz, (già presidente del consiglio di sorveglianza di BlackRock in Germania), ha annunciato una svolta verso liberismo e riarmo, abbandonando la tradizionale “terza via“. Come notato da qualche analista si tratterebbe di un ritorno al liberismo classico, con l’aggiunta pericolosa del warfare in sostituzione del welfare.
Il peso della Germania nell’Europa
L’Eurozona riflette l’ordoliberalismo tedesco:
• I vincoli del Patto di Stabilità (deficit <3%, debito <60%) riflettono la centralità della disciplina fiscale;
• La BCE è ispirata alla Bundesbank: indipendente e concentrata sulla stabilità dei prezzi;
• La politica monetaria europea ha storicamente evitato il sostegno diretto agli Stati.
• Alleanza con i “Paesi frugali” (Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Svezia e Finlandia), che insieme controllano il 40% del PIL UE.
La Grande Germania dei paesi frugali
Il blocco Germania-Paesi frugali potremmo definirlo Germania estesa (Erweitertes Deutschland) o, con una qualche malizia, Grande Germania (Großdeutschland), o magari, dopo le recenti esternazioni di Metz, Nuova Prussia (Neupreußen), ed esercita un’egemonia politica attraverso: .
• Potere di veto nel Consiglio UE (27% della popolazione);
• Influenza sulla Commissione Europea (es. Ursula von der Leyen);
• 186 seggi al Parlamento Europeo (26% del totale).
Tuttavia, il modello mostra limiti strutturali: mentre i Paesi frugali mantengono welfare generosi (spesa sociale al 42-47% del PIL), l’Italia (30%) e gli altri paesi subiscono crescenti disuguaglianze fino alla Grecia vittima di austerity estrema).
Una comparazione con l’Italia d’oggi
Per comprendere meglio il potere attrattivo del modello “ordoliberalista” nella variante “Grande Germania” si propone una tabella comparativa con il caso italiano che è di tipo familista, bassa spesa sociale, inefficienza redistributiva e servizi pubblici carenti. Alta evasione fiscale. In contrasto con l’efficienza e l’universalità del modello frugale.
Modello prevalente
Paesi frugali : Socialdemocratico / Liberale sociale
Italia : Mediterraneo / familista
Spesa sociale / PIL
Paesi frugali : 42–47% (molto alta)
Italia : ~30% (media UE)
Distribuzione spesa
Paesi frugali : Equilibrata tra pensioni, famiglia, sanità
Italia : Sbilanciata su pensioni
Efficacia redistributiva
Paesi frugali : Alta (oltre 30% dei poveri escono dalla soglia)
Italia : Bassa (circa 20%)
Servizi pubblici
Paesi frugali : Universali, accessibili, di qualità
Italia : Discontinui, spesso affidati al privato
Compliance fiscale
Paesi frugali : Alta, con consenso sociale
Italia : Bassa, con evasione diffusa
La diseguaglianza europea fattore di crisi
Il modello ordoliberalista adottato entro i confini della Grande Germania si basa su politiche economiche tese a garantire gli interessi propri ma non quelli degli altri paesi europei.
Prendiamo due casi emblematici del fallimento del modello ordoliberale con vantaggi ad area ristretta
Italia: Rigore e margini di manovra ridotti
• Le regole fiscali europee ispirate all’ordoliberalismo (come il limite del 3% sul deficit e il 60% sul debito/PIL) hanno vincolato l’Italia nelle sue politiche economiche.
• Nei momenti di crisi, l’Italia ha faticato a stimolare l’economia tramite spesa pubblica o investimenti, per non violare i parametri europei.
• L’alto debito ha portato a continue pressioni da Bruxelles e Francoforte per “aggiustamenti strutturali”, inclusi tagli alla spesa e riforme del lavoro. Lo smantellamento dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori nonché delle istituzioni democratiche è ampiamente attribuito dalla opinione pubblica all’Unione europea ed alla sua conduzione “grantedesca”.
Grecia: un caso ancor più emblematico
• Durante la crisi del debito sovrano (2010), la Grecia è stata costretta ad adottare misure di austerità radicali in cambio di aiuti finanziari dai partner europei e dal FMI.
• Queste politiche, fortemente ordoliberiste, hanno avuto effetti devastanti: disoccupazione altissima, impoverimento della popolazione e tensioni sociali.
• La gestione della crisi greca ha mostrato i limiti dell’ordoliberalismo in contesti di grave recessione, dove la rigidità ha aggravato anziché risolvere i problemi.
• Nella opinione pubblica europea l’annientamento del paese ha suscitato un forte senso di disgusto, ed è stata valutata come atto gratuito e particolarmente odioso, punitivo di un governo socialista, tenuto conto anche del fatto che l’irrilevanza della Grecia sul piano dell’economia globale, non avrebbe compromesso la stabilità del bilancio europeo.
Guerra alla Russia, il de profundis dell’ordoliberalismo, e dell’Europa
Senza entrare nel merito del giusto e dell’ingiusto, dell’invasore e dell’invaso, della ragione e del torto, la Guerra d’Ucraina ha creato una serie di condizioni che preannunciano una crisi molto probabilmente irreversibile dell’Unione europea come la conosciamo.
• La Guerra ha rotto l’asse portante del motore economico tedesco (e di quello europeo). Ha rotto anche il felice partenariato che si era stabilito tra Russia (fornitore di energia a basso costo e importatore di prodotti finiti) e Germania, la fabbrica d’Europa con la partecipazione nella catena del valore di tutti i paesi europei.
• La nuova situazione è destinata a provocare sconvolgimenti nelle relazioni tra i paesi dell’Unione, anche in quelli del fronte dei frugali
• La crisi favorisce la penetrazione dei gruppi finanziari americani nel controllo degli apparati e istituzioni ancora europei
• i paesi dell’Unione saranno costretti all’acquisto di prodotti americani, magari con una triangolazione perversa (produzione in casa dei prodotti che verranno venduti da aziende americane agli stessi paesi che li hanno prodotti)
• Si dovrà dire addio al welfare anche da parte dei paesi che ancora ce l’hanno in favore del warfare
• La soluzione di sostituire la spesa improduttiva del welfare con quella del warfare non riuscirà a mantenere il livello dell’attuale ciclo economico, non solo per gli effetti sociali destabilizzanti, ma per la ratio stessa che rende incompatibili i due modelli.
• La rinuncia ad una risposta unitaria europea al nuovo patronage americano renderà i singoli paesi divisi facile preda del capitale Usa.
• Quindi niente ordoliberismo, niente Europa unita, niente Europa.
• A meno che … il Re-arm tedesco. Come nel 1933?
Conclusione
L’ordoliberalismo, già in crisi prima della guerra in Ucraina, appare oggi un modello insostenibile. La Germania, di fronte alla rottura con la Russia, ha manifestato l’intenzione di abbandonare la “terza via” per abbracciare liberismo e riarmo, minando le basi stesse dell’integrazione europea. Il futuro dell’UE dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra sovranità nazionale e cooperazione, evitando tanto la sottomissione agli USA quanto la deriva autoritaria. Le scelte della Germania saranno determinanti. Se prevarrà la scelta del Re-Arm si passerà necessariamente da un modello ordoliberale ad uno dirigista, ma prostrato agli interessi del capitale finanziario americano, il che provocherà un ulteriore arretramento dei livelli di democrazia ancora presenti e aumenterà in maniera esponenziale il tradizionale ruolo di servaggio nei cfr del padrone americano mentre sarà irrilevante nei confronti del nemico inesistente russo o cinese. Lo stile comunicativo di Trump ha reso palese a tutti i reali termini della questione, la stessa del Marchese del Grillo. La Germania potrebbe indicare la via, unica, di difesa dell’Europa, che sicuramente non è quella del riarmo, che tra l’altro non farebbe che aumentare i vincoli nei cfr degli Usa, economici e strategici.
Postfazione
Le riflessioni fin qui sviluppate si concentrano esclusivamente sugli aspetti socioeconomici e istituzionali interni ai Paesi europei, con particolare riferimento alla Germania e al suo ruolo nell’evoluzione dell’Unione Europea. Alcuni nodi fondamentali, pur cruciali per una lettura più completa del quadro geopolitico, sono stati intenzionalmente esclusi dal perimetro dell’analisi. È opportuno tuttavia richiamarli brevemente:
1. L’influenza americana come cornice geopolitica
Non è stato approfondito il ruolo strutturale esercitato dagli Stati Uniti nel condizionare direttamente la politica interna ed estera di paesi chiave come la Germania o l’Italia. Tale influenza si manifesta attraverso una rete multilivello fatta di basi militari permanenti, dispositivi finanziari, intelligence condivisa e leve diplomatico-economiche. Dopo la fine dell’Unione Sovietica, questa egemonia si è ricalibrata: da logica bipolare contenitiva, verso una funzione di tutela dell’ordine unipolare statunitense, con l’Europa subordinata più che mai alle priorità strategiche di Washington. Questo mutamento profondo della dottrina americana in Europa non è stato qui trattato, se non con un rapido accenno, irrilevante nel contesto dell’articolo.
2. Il ruolo oscuro dell’élite tecnocratica europea
Nel presente lavoro si è scelto di non approfondire una questione cruciale quanto delicata: la natura del potere decisionale nell’Unione Europea e della burocrazia che la amministra.
Il vertice di questa tecnocrazia è composto da Grand Commis e non è formalmente eletto, ma viene designato in base alla competenza che l’ufficio richiede. Nella realtà ciò avviene sulla base della rete di relazioni che lega questa élite ai centri decisionali del potere finanziario globale, in particolare quelli di matrice statunitense.
Tale osmosi tra apparati europei e interessi finanziari contribuisce a spiegare le macroscopiche incongruenze della politica europea, che opera spesso contro gli interessi dei propri membri e dell’istituzione nel suo insieme.
In questo senso, l’Unione Europea non è più solo una comunità di Stati sovrani ma anche una struttura tecnocratica che risponde – direttamente o per via indiretta – agli orientamenti dell’élite economica, il cui baricentro è e rimane negli Stati Uniti.
3. Limiti dell’analisi puramente economica
In conclusione, il lavoro si è concentrato sull’analisi comparativa tra diversi modelli economici—ordoliberismo, economia mista e welfare—scegliendo consapevolmente di non affrontare le implicazioni politiche e geopolitiche associate ai vari assetti istituzionali. Il legame tra modello economico e democrazia, così come tra sovranità economica e autonomia strategica, rappresenta un ambito che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Nelle conclusioni si accenna infatti all’ipotesi di una possibile evoluzione dell’Europa da spazio di welfare a spazio di warfare—una trasformazione che, per la sua portata e le conseguenze trasversali sull’intera comunità, richiederebbe un’analisi dedicata.
Ordoliberalismo e Miracolo Tedesco: L’Europa alla Svolta? Dalla ricostruzione postbellica alla crisi attuale, il modello ordoliberale tedesco ha plasmato l’economia europea. Ma con l’abbandono del welfare a favore del warfare, la Germania rischia di trascinare l’UE verso un declino irreversibile. Tra austerità, guerre energetiche e subalternità agli USA, l’Europa è a un bivio: riarmo o…