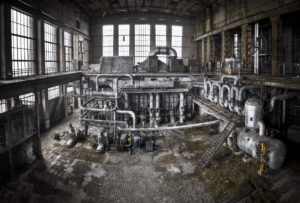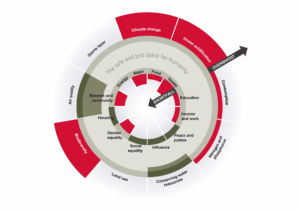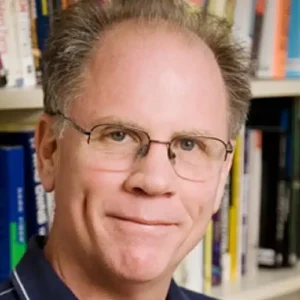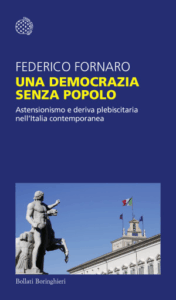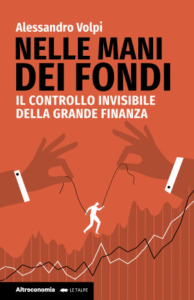Comunità beni comuni e socialismo MR 2025-03
Un numero speciale sulle comuni nell’edificazione socialista
di Chris Gilbert e Cira Pascual Marquina
Il testo originale è nel sito Monthly Review 2025-03
Abstract by Deepseek
Questo numero speciale di Monthly Review esplora il ruolo delle comuni nella costruzione del socialismo, prendendo spunto dall’esperienza venezuelana del movimento comunale bolivariano. Ispirato dal discorso di Hugo Chávez sul “Golpe de Timón” (2012), il volume analizza come le comuni – intese come cellule territoriali di autogoverno popolare e produzione sociale – rappresentino un modello per coniugare potere statale rivoluzionario e democrazia di base. Attraverso contributi teorici e casi di studio, si esaminano le radici storiche (dalle comunità indigene alle occupazioni di fabbriche), le sfide (burocrazia, imperialismo) e le potenzialità di questo approccio, proponendolo come alternativa concreta alle crisi del capitalismo globale e all’astrattezza di certi marxismi contemporanei.
Scheda Sintetico-Analitica by Deepseek
1. Contesto e Oggetto
- Focus: Le comuni come strumento di edificazione socialista, con case study dal Venezuela bolivariano.
- Origine: Il progetto fu lanciato da Chávez nel 2009 e ripreso recentemente dal governo Maduro, dopo una fase di stallo.
- Definizione: Strutture territoriali (fino a 10.000 persone) che integrano democrazia politica ed economia sociale, superando i limiti dei consigli comunali (più piccoli e solo politici).
2. Approccio Teorico
- Dualismo potere statale/popolare: Critica alle tendenze “orizzontaliste” (es. zapatismo) e ai marxismi eurocentrici, a favore di un modello ibrido che combina istituzioni statali e autorganizzazione di base.
- Radici materiali: Ispirazione dalle tradizioni indigene (es. cumbes, comunità afro-venezuelane) e dalle lotte recenti (occupazioni di terre/fabbriche).
- Autocritica: Superamento di errori passati (es. fabbriche co-gestite burocratizzate) attraverso assemblee deliberative e proprietà sociale.
3. Contributi Chiave
- Lezioni dal Venezuela:
- Sperimentazione istituzionale (dai comitati per l’acqua alle comuni).
- Necessità di scala adeguata (né troppo piccola né statalista).
- Risposta all’imperialismo (sanzioni, guerra economica) attraverso resilienza comunitaria.
- Sfide globali:
- Crisi ecologica e frattura metabolica.
- Oppressione di genere/razza nel lavoro riproduttivo.
- Rischio di feticismo del “locale” senza strategia statale centralizzata.
4. Critica al Marxismo Contemporaneo
- Divorzio dalla prassi: Denuncia dell’accademismo marxista eurocentrico, distante dai movimenti rivoluzionari del Sud globale.
- Proposta: Un marxismo “applicato” che parta dalle lotte reali (es. Venezuela, Palestina, Cina) e le teorizzi a posteriori.
5. Articoli Selezionati (Temi trattati)
- Interviste a attivisti comunardi venezuelani.
- Analisi comparative con esperienze storiche (Comune di Parigi, Rojava).
- Dibattito su democrazia partecipativa e pianificazione ecologica.
6. Citazioni Iconiche
- “Inventamos o erramos” (Simón Rodríguez): La sperimentazione come metodo.
- “La comune è la cellula del socialismo” (Chávez): Centralità del territorio.
- “Senza potere popolare istituzionalizzato, la rivoluzione muore” (Mészáros).
Tabella Riassuntiva
| Elemento | Vantaggi | Rischi |
|---|---|---|
| Comuni | Democrazia sostanziale, anti-burocrazia | Isolamento, scarsa coordinazione |
| Dualismo Stato/base | Flessibilità, radicamento popolare | Tensioni istituzionali |
| Modello venezuelano | Adattamento all’imperialismo | Dipendenza da leadership carismatica |
Conclusione
Il volume propone le comuni come laboratori di socialismo dal basso, capaci di affrontare le crisi sistemiche (dall’ecologia all’imperialismo). Tuttavia, avverte: senza un progetto statale anticapitalista e una strategia internazionalista, rischiano di rimanere esperimenti isolati.
Parole chiave: Comuni, Venezuela, Potere popolare, Marxismo applicato, Imperialismo.
Per approfondire:
- Gilbert, ¡Comuna o Nada! (2023)
- Harnecker, Il socialismo del XXI secolo (2010)
- Prashad, Le nazioni più oscure (2007).
Versione tweetabile (280 caratteri):
“Dalle comuni venezuelane al socialismo del XXI secolo: come combinare potere statale e autogestione popolare? Un numero speciale di @MonthlyReview esplora modelli concreti per sfidare capitalismo e imperialismo. #Chavez #MunicipalismoLibertario”
Poco prima di morire, Hugo Chávez pronunciò il suo famoso discorso “Golpe de Timón” in un incontro televisivo nazionale con il suo gabinetto ministeriale. Quel discorso ha ripetutamente menzionato la questione delle comuni e del loro ruolo nella costruzione socialista. Nel corso di diverse ore, Chávez ha insistito sul fatto che la costruzione di una comune dovrebbe essere promossa da tutti i membri del suo gabinetto, e ha detto specificamente al futuro presidente Nicolás Maduro che gli ha affidato il progetto della comune “come la sua stessa vita”.1 Nel tempo trascorso dalla morte di Chávez, il progetto comunale venezuelano ha avuto una traiettoria irregolare. All’inizio, la costruzione delle comuni sembrava cadere nel dimenticatoio nella lotta per sopravvivere all’intensificarsi degli attacchi imperialisti contro il paese. In seguito, è riemerso come un progetto guidato principalmente dalle basi più impegnate del chavismo. Negli ultimi due anni, tuttavia, il governo stesso è tornato esplicitamente al progetto comunale con rinnovato sostegno ed entusiasmo, unendosi di fatto alle basi comunarde del Venezuela ancora una volta in un modo che sembra particolarmente propizio per la costruzione socialista.
Questo numero speciale della Rivista Mensile sul tema delle Comuni nell’edificazione socialista è stato ispirato dal movimento comunale venezuelano, che ha avanzato una strategia di edificazione socialista che, a nostro avviso, merita di essere considerata come un contributo al corpo universale del pensiero socialista. Al fine di affrontare le numerose questioni sollevate da tale proposta, abbiamo riunito una serie di contributi. Alcuni esaminano l’iniziativa venezuelana e quelle affini, mentre altri approfondiscono i fondamenti teorici (principalmente marxisti) del progetto di costruzione del socialismo attraverso la comune. Dato che l’ispirazione per affrontare questo tema viene dal movimento comunale venezuelano, vale la pena esaminare brevemente la storia di questo progetto e come è emerso dal processo rivoluzionario bolivariano.
Nei primi anni della rivoluzione venezuelana, molti hanno notato che una delle sue caratteristiche più distintive era lo sforzo costante di combinare la politica a livello statale con il potere popolare di base. Ad esempio, l’esperto studioso di storia venezuelana Steve Ellner ha notato come la rivoluzione abbia impiegato contemporaneamente due approcci, uno che era “dal basso”, coinvolgendo il potere popolare e la base, e un altro che era “dall’alto”, che coinvolgeva lo stato e il governo.2 Ciò che era importante nell’approccio venezuelano è che, a differenza dello zapatismo e di altri movimenti contemporanei che avevano in gran parte messo da parte la questione del potere statale, il movimento bolivariano ha effettivamente preso il potere politico nel 1999. Da lì, andò avanti utilizzando sia il potere statale trasformato che la costruzione di base nel perseguimento del progetto di liberazione nazionale che chiamò la “Seconda e Vera Indipendenza”.
Questo duplice approccio, sosteniamo, è stato un contributo chiave della rivoluzione venezuelana. Al contrario, molti hanno indicato il “socialismo del XXI secolo”, che Chávez ha annunciato come progetto nazionale nel 2006, come il contributo più importante della rivoluzione venezuelana ai dibattiti di sinistra contemporanei. Tuttavia, riteniamo che questa attenzione sia troppo vaga, poiché elude l’importantissima questione di come il progetto del socialismo dovesse essere perseguito e materializzato. Questo ci porta al secondo grande contributo del Processo Bolivariano al progetto della sinistra, che è meno riconosciuto ma strettamente legato alla già citata combinazione di potere di base e potere statale rivoluzionario: la continua ricerca di forme organizzative e istituzionali concrete che potrebbero rendere la combinazione di poteri di base e Stato in una realtà vibrante.
Come per il primo contributo alla teoria e alla pratica della sinistra, questo può essere meglio compreso in relazione al contesto storico dell’emergere della rivoluzione. Dagli anni ’90, c’è stata una celebrazione quasi mondiale del potere di base, con una parte molto visibile dell’intellettualità di sinistra che si è fatta poetica sull'”orizzontalità”, sulle “logiche dello sciame” o sulla “potenza della moltitudine”. Eppure il processo bolivariano ha fatto un passo epocale quando, in contrasto con tale retorica dagli occhi annebbiati, ha lavorato per creare una serie di istituzioni concrete di potere popolare, che sono state trasformate in legge. Sviluppando forme organizzative e istituzioni che sono state attivamente sponsorizzate dallo stato, l’idea di empowerment popolare ha cessato di esistere come una stravaganza postmoderna ed è diventata invece una realtà organizzativa all’interno di un movimento nazionale.
La traiettoria della rivoluzione venezuelana di sperimentazione con le istituzioni di base ha avuto diversi successi degni di nota, tra cui i comitati di gestione dell’acqua (2001), i comitati urbani per la terra (2002) e i comitati per la salute (2003) prima di approdare ai consigli comunali (2006), che hanno costituito un’importante pietra miliare. Il consiglio comunale è stato concepito come un’istituzione prevalentemente politica e molto locale (coinvolgeva circa duecento famiglie nelle aree urbane e un centinaio nelle aree rurali), ma era estremamente importante perché era attuato a livello nazionale. Dal consiglio comunale, fu un passo relativamente breve, anche se significativo, per formare la più ampia struttura dei comuni, che combinava la democrazia politica ed economica di base. Chávez ha dichiarato che le comuni sono le “cellule fondamentali” del socialismo venezuelano nel 2009. Attraverso questa dichiarazione e impegnandosi in un continuo lavoro pedagogico e legislativo per sostenerla, Chávez stabilì il progetto di costruire il socialismo attraverso la comune come spina dorsale della rivoluzione.
Vale la pena sottolineare che la pratica del movimento bolivariano di combinare forme di base come i consigli comunitari e le comuni con il potere statale rivoluzionario non era solo un correttivo agli errori e alle limitazioni di movimenti come lo zapatismo che esistevano all’epoca. È stata anche una risposta ad alcuni dei problemi affrontati da una precedente ondata di processi di liberazione nazionale del XX secolo. Perché i progetti di liberazione nazionale nei paesi del Sud del mondo che hanno ispirato tante speranze durante la seconda metà del secolo scorso – un movimento radicale e glorioso che ha sfidato l’egemonia coloniale, capitalista e imperialista per decenni – si sono rivelati, in molti paesi, limitati dall’incapacità di mantenere un legame organico con le masse a lungo termine. Questa è la conclusione che emerge dalle migliori indagini di quel periodo, come il classico di Vijay Prashad The Darker Nations.3 Il Processo Bolivariano ha affrontato questo problema non solo attraverso la sua costante promozione discorsiva del potere popolare e della partecipazione di massa, ma, come abbiamo detto, costruendo forme istituzionali attraverso le quali il potere popolare potesse essere costruito e mantenuto, con la comune che era la più sviluppata.
Da quanto sopra, dovrebbe essere chiaro che la comune venezuelana non è caduta dal cielo o è uscita dalla testa di nessuno come si suppone che Atena sia emersa da quella di Zeus. È vero che illustri intellettuali marxisti come Marta Harnecker e István Mészáros, insieme allo stesso Chávez, hanno svolto un ruolo chiave nella concettualizzazione. Tuttavia, nonostante i loro importanti contributi, la comune venezuelana dovrebbe essere vista principalmente come sviluppatasi attraverso un processo di sperimentazione complesso, a volte tortuoso, che è stato spesso giustificato dallo slogan del pedagogo venezuelano Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos” (“Inventiamo, o sbagliamo”). Una parte importante delle radici materiali delle comuni socialiste venezuelane risale alla lunga storia della regione di autogoverno indigeno e afro-venezuelano resistente, che include comunità maroon chiamate cumbes che un tempo esistevano in gran parte del territorio venezuelano. In un senso più prossimo, il modello della comune si basava sulle recenti esperienze del Venezuela di occupazioni di fabbriche e latifondi, e sui suoi sforzi per l’organizzazione territoriale.4
Nella lunga traiettoria che ha portato alla Comune, l’autocritica ha chiaramente giocato un ruolo importante. Ad esempio, per superare i limiti di alcune delle iniziative più piccole, la comune doveva essere relativamente grande e completa, coinvolgendo ciascuna fino a diecimila persone. La comune doveva anche trascendere il carattere meramente politico dei consigli comunitari per includere una dimensione economica, in particolare i mezzi di produzione sotto il regime della proprietà sociale (incorporando così le lezioni del materialismo storico riguardo alla centralità della produzione). Inoltre, per correggere la burocrazia delle fabbriche co-gestite e il loro ristretto focus sui punti di produzione, la comune venezuelana ha promosso la democrazia partecipativa nelle assemblee e nei parlamenti comunali, mirando ad estendere il controllo democratico a tutta la vita comunale. Sottolineando quest’ultimo, Chávez ha detto che il processo di costruzione socialista deve essere giudicato dal grado in cui ha attuato una democrazia sostanziale complessiva nelle comunità.5
Identificando e sottolineando il progetto che ci ha ispirato, vogliamo chiarire come il tema di questo numero speciale sia emerso non a causa di una tesi astratta sul socialismo, ma perché un progetto rivoluzionario del mondo reale ci ha portato a considerare il ruolo dei modelli comunitari nei progetti socialisti. Siamo convinti che la ragione principale per cui tanto marxismo oggi ha cessato di essere rivoluzionario è proprio il suo divorzio dall’attività rivoluzionaria. Questa separazione non era una caratteristica dell’opera di Karl Marx, che si impegnava continuamente con i movimenti più radicali del suo tempo, ma è piuttosto il risultato di come oggi così tanto studio marxista sia incoraggiato e promosso in strutture istituzionali che sono lontane dalle vere molle dell’attività rivoluzionaria, che attualmente esistono principalmente nel Sud del mondo. In questo modo, fortemente condizionato dal suo contesto sociale non rivoluzionario, una parte importante del marxismo del nostro tempo è diventato non solo eurocentrico, ma anche eccessivamente idealista, in quanto si sviluppa autonomamente dalla realtà materiale dell’attuale spinta rivoluzionaria sudcentrica.
Nello sviluppo di questo numero speciale della Monthly Review, come nei nostri lavori precedenti, abbiamo cercato di seguire l’approccio opposto, che riteniamo essere quello marxista originale.6 Questo approccio implica l’impegno con veri movimenti rivoluzionari e l’uso del metodo marxista e del corpo di pensiero che ne deriva per interpretare e accompagnare i loro sviluppi. Questo approccio non è un “raccoglimento in tranquillità” accademico, ma è piuttosto un materialismo storico applicato nel “momento del pericolo”, come avrebbe detto Walter Benjamin.7 Sebbene il nostro punto di partenza e la nostra ispirazione sia la rivoluzione venezuelana, abbiamo gettato una rete più ampia in questo numero, guardando a proposte simili nel tentativo di far emergere conoscenze condivise e connessioni tra progetti affini. Questa ricerca di punti di contatto ed elementi congrui è una procedura essenziale nel quadro della scienza marxista, poiché al di là delle specificità del movimento venezuelano, appartiene al progetto universale di costruzione socialista e quindi condivide numerose intersezioni e punti in comune con altri processi in tutto il mondo.
Tra le sfide comuni della costruzione socialista evocate dall’esperienza venezuelana – alcune delle quali sono affrontate negli articoli qui riuniti – ci sono: la già citata questione di coniugare il potere statale (post)rivoluzionario con la partecipazione di base; la questione di come realizzare la costruzione socialista in un mondo attraversato da un imperialismo che ha un carattere sempre più sterminista (che si esprime in guerre genocide e sanzioni); la necessità di affrontare l’intera gamma della dominazione sociale capitalista, che si manifesta non solo nello sfruttamento della forza lavoro, ma anche nell’oppressione che è radicata nelle strutture di genere e razzializzate del lavoro riproduttivo non retribuito o sottopagato; e la questione di come superare la frattura metabolica che il capitalismo introduce tra processi sociali e naturali, con conseguenze che sono particolarmente disastrose per i popoli e le nazioni del Sud del mondo. In relazione a tutte queste sfide, il modello comunale si è dimostrato un formato promettente e flessibile proprio perché è una forma globale di organizzazione sociale e territoriale che consente la riorganizzazione deliberata delle dimensioni politiche, economiche e persino culturali della vita.
Questo numero speciale raccoglie una serie di articoli e interviste, insieme a un testo storico, tutti collegati in un modo o nell’altro al progetto di costruzione socialista attraverso la comune. Nel sollecitare contributi, abbiamo incoraggiato gli autori a mantenere il dibattito sulle comuni in dialogo con il più ampio progetto di lotta antimperialista e socialista. Abbiamo anche chiesto loro di evitare atteggiamenti idilliaci nei confronti delle comuni passate o esistenti, che incarnano un’eredità complessa che non è necessariamente favorevole al socialismo. Infine, abbiamo evidenziato la necessità di evitare di feticizzare le comunità decentrate nel modo tipico degli approcci “piccolo è bello” e anarchici, che ignorano pericolosamente la necessità di una strategia centralizzata di Stato e di partito per avanzare in un mondo attraversato dall’imperialismo, per non parlare di una crisi ecologica che trascende qualsiasi soluzione meramente locale. Alla fine, tuttavia, furono gli scrittori stessi, il cui impegno sia per le lotte della vita reale che per l’eredità del marxismo garantirono un approccio sobrio e rigoroso alla comune. Hanno risposto con contributi che, pur nella loro diversità, sono accomunati da un approccio alla costruzione comunitaria che enfatizza il contesto, le condizioni e la strategia, pur mantenendo in vista la totalità delle relazioni sociali e materiali.
Mentre scriviamo queste righe, il mondo è entrato in una crisi di una profondità mai vista prima nella nostra vita. Tra le espressioni di questa crisi ci sono l’assalto genocida in corso a Gaza da parte di Israele e degli Stati Uniti e la Nuova Guerra Fredda che Washington sta promuovendo contro la Cina e il Sud del mondo. Nel frattempo, il degrado ambientale procede a ritmo sostenuto. Molti riconoscono quanto sia grave la situazione, e le denunce da parte di individui e collettivi sono cresciute negli ultimi anni. Tali proteste sono necessarie e devono essere estese. Tuttavia, se rimaniamo solo nell’atto di denuncia, veniamo meno alla missione storica della sinistra marxista, che è stata quella di combinare la denuncia e la critica con il progetto di promuovere e accompagnare il movimento reale dei lavoratori verso la loro emancipazione. In questo senso, è un segno di terreno perduto che l’energia della sinistra oggi vada per lo più in protesta e analisi critica, mentre così poco sforzo è diretto a comprendere e promuovere l’attuale costruzione di alternative, che si tratti del progetto cinese di costruire una civiltà ecologica e socialista, della ricerca della resistenza palestinese della liberazione nazionale, o il progetto socialista che si sta costruendo in Venezuela. Speriamo che questo numero speciale della Monthly Review contribuisca a correggere questo errore e quindi a ripristinare il lato attivo del marxismo.
Note
- ↩ Hugo Chávez, traduzione inglese: “Strike at the Helm (October 20, 2012),” trad. Jamie Weiss, MR Online, 1 aprile 2015, mronline.org.
- ↩ Steve Ellner, Ripensare la politica venezuelana: classe, conflitto e il fenomeno Chávez (Londra: Lynne Reinner, 2008), vedi capitolo 7.
- ↩ Vijay Prashad, Le nazioni più oscure: una storia popolare del Terzo Mondo (New York: The New Press, 2007).
- ↩ Chris Gilbert, Comune o niente!: Il movimento comunale venezuelano e il suo progetto socialista (New York: Monthly Review Press, 2023), capitolo 4.
- ↩ Chávez ha citato l’affermazione di Mészáros secondo cui “Il metro di paragone… delle conquiste socialiste è la misura in cui le misure e le politiche adottate contribuiscono attivamente alla costituzione e al consolidamento profondamente radicato di un sostanziale democratico… modalità di controllo sociale generale e di autogestione”. Chávez, “Colpisci il timone”.
- ↩ Si veda Cira Pascual Marquina e Chris Gilbert, Venezuela, The Present as Struggle (New York: Monthly Review Press, 2020); Gilbert, Comune o niente!; Chris Gilbert e Cira Pascual Marquina, Resistencia comunal frente al bloqueo imperialista book series (Caracas: Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2021–2025).
- ↩ Walter Benjamin, “On the Concept of History”, in Selected Writings, vol. 4, a cura di Howard Eiland e Michael Jennings (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006), tesi VI, 391.
2025, Volume 77, Numero 03 (Luglio-Agosto 2025)