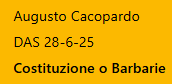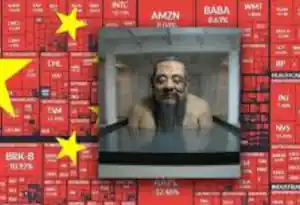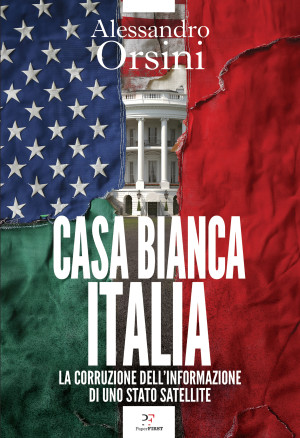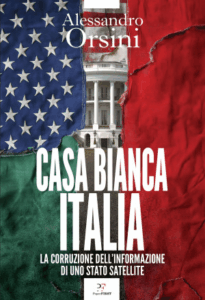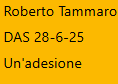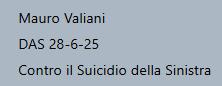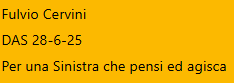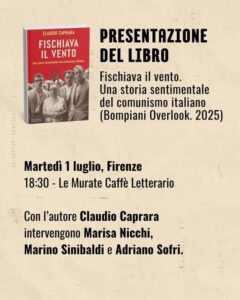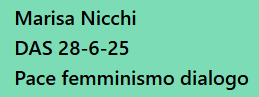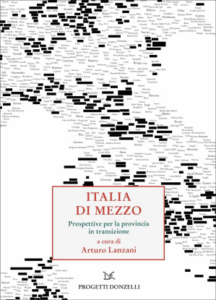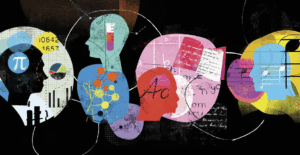Dal Giappone all’Italia e alla Cina: i limiti del liberismo di Gian Luigi Betti
Premessa
Il Giappone, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sembrò aver imboccato una traiettoria di sviluppo che lo trasformò in una delle principali potenze industriali del mondo. Negli Stati Uniti questo suscitò forti preoccupazioni: prese piede una campagna mediatica contro i prodotti giapponesi (un po’ come quello che sta succedendo ora con quelli cinesi) e si arrivò perfino a demolire automobili nipponiche a colpi di martello in diretta TV, in difesa del “made in USA”. Partendo dalla lettura di un breve saggio pubblicato dalla Newsletter “Il Punto” dedicato alla bolla speculativa giapponese dei primi anni Novanta – che, su scala locale, può essere considerata un’anticipazione di quella globale del 2008 – propongo qui alcune riflessioni, con lo stile di un osservatore “neutro” (quale in realtà non sono), che accetta il principio della riformabilità (e sopravvivenza) del capitalismo monopolistico, rinunciando quindi ad ogni approccio che sappia di marxismo.
Gian Luigi Betti
Presentazione di Deepseek
Titolo della presentazione:
Dal Giappone alla Cina: lezioni di capitalismo politico e i limiti del liberismo
Introduzione
L’articolo ripercorre l’ascesa e il declino del modello giapponese del dopoguerra, mettendolo a confronto con le esperienze italiane e cinesi per criticare i dogmi del liberismo globale. Partendo dalla bolla speculativa giapponese degli anni ’90 (anticipatrice della crisi del 2008), Betti analizza come l’intervento statale sia stato cruciale per lo sviluppo industriale, mentre la deregolamentazione e le pressioni geopolitiche abbiano innescato crisi profonde.
Sezione 1: Il successo del capitalismo politico
- Il modello giapponese
- Combinazione di intervento statale, pianificazione industriale e collaborazione tra pubblico e privato.
- Esempi: Toyota e Sony diventano leader globali grazie a politiche pubbliche mirate (credito agevolato, protezione settoriale).
- Contro la narrazione del “mercato onnisciente”: lo Stato come regista dello sviluppo.
- L’esperienza italiana
- Miracolo economico trainato da imprese pubbliche (ENI, IRI) e private (Fiat) in coordinamento con lo Stato.
- Welfare democristiano e credito agevolato come motori di crescita, senza compromettere la stabilità.
Sezione 2: La crisi e le sue cause
- La trappola giapponese
- Accordi del Plaza (1985): la rivalutazione forzata dello yen (+51%) danneggia le esportazioni.
- Politica monetaria iper-espansiva (tassi a zero) → bolla immobiliare/azionaria → crollo e “decennio perduto”.
- Colpe non del capitalismo politico, ma della deregolamentazione e delle pressioni USA.
- Confronto con la Cina
- Stesso modello di capitalismo politico, ma con maggior resistenza alle pressioni esterne (es. cambio valutario).
- Economia e demografia cinese rendono più difficile una destabilizzazione come quella del Giappone.
Sezione 3: Lezioni attuali e critica al liberismo
- Fallimenti del dogma liberista
- La mano invisibile e il mercato autoregolato sono miti: servono regole pubbliche per evitare bolle e crisi.
- Esempi: deindustrializzazione italiana, stagnazione giapponese, crisi finanziarie globali.
- Geopolitica ed egemonia USA
- Negli anni ’80-90, USA e UE impongono deregolamentazione e libera circolazione dei capitali.
- La sinistra occidentale (New Labour, Terza Via) rinuncia a modelli alternativi, accelerando la finanziarizzazione.
- La sfida odierna
- In un mondo multipolare (BRICS+), la Cina dimostra che alternative al liberismo sono possibili.
- Necessità di riscoprire un protagonismo pubblico: pianificazione strategica, difesa dell’industria, coesione sociale.
Conclusione
Key message:
- La storia economica del Giappone e dell’Italia mostra che il successo nasce da un equilibrio tra Stato e mercato, non dal liberismo sfrenato.
- Oggi, la Cina incarna un capitalismo politico più resiliente, mentre l’Occidente paga il prezzo della finanziarizzazione.
- Urgenza politica: ripensare l’economia mista e sottrarsi all’egemonia ideologica del mercato assoluto.
Domande aperte:
- Può l’Europa tornare a un modello di economia mista senza rompere con l’UE liberista?
- Come evitare che la competizione USA-Cina generi nuove crisi sistemiche?
Stile della presentazione:
- Adatta a un pubblico accademico o politico, con tono critico ma non ideologico (come richiesto dall’autore).
- Possibile arricchimento con dati: es. PIL Giappone 1990-2000, crescita debito cinese, confronto tassi di intervento.
Slide aggiuntive:
- Grafico: Andamento PIL Giappone (1980-2000) vs. Cina (2000-2020).
- Mappa: Paesi BRICS+ e peso nel PIL globale.
- Citazione chiave: “La Cina di oggi non è il Giappone del 1989”.
Questa struttura mantiene la neutralità formale dell’autore, pur evidenziando la tesi centrale: la necessità di alternative al liberismo per evitare crisi cicliche e declino industriale.
Dal Giappone all’Italia e alla Cina: lezioni di capitalismo politico e i limiti del liberismo
Quando si ripercorre la parabola dell’economia giapponese tra gli anni ’50 e ’90, si resta colpiti dalla straordinaria capacità di un Paese sconfitto e distrutto di trasformarsi, in poche decadi, nella seconda potenza industriale mondiale. Altrettanto impressionante è però la rapidità con cui quel miracolo si trasformò in stagnazione cronica. Un’esperienza che offre lezioni fondamentali per comprendere i limiti del liberismo incontrollato e le attuali dinamiche geoeconomiche tra Stati Uniti, Cina e il resto del mondo.
Il Giappone conobbe il proprio boom grazie a un modello di capitalismo politico: una combinazione di intervento statale, pianificazione industriale, credito agevolato e collaborazione tra ministeri, banche e grandi conglomerati. Questo approccio smentiva la narrazione ideologica del “mercato onnisciente” dominante in Occidente e mostrava come una strategia pubblica oculata potesse stimolare innovazione, crescita e competitività globale. Non furono gli “spiriti animali” del libero mercato a fare di Toyota o Sony dei campioni mondiali, bensì politiche mirate di investimento, sostegno alla ricerca e protezione dei settori strategici.
Anche in Europa non mancarono esperienze analoghe. Il miracolo economico italiano del dopoguerra vide la crescita di grandi imprese pubbliche e private -dall’ENI di Mattei alla Fiat, dall’IRI alle banche di interesse nazionale – che agirono da motore di sviluppo in stretto coordinamento con lo Stato. L’industria pubblica e il credito agevolato permisero di costruire un tessuto produttivo moderno, capace di competere sui mercati internazionali e di trainare l’occupazione. Anche l’Italia dimostrò che l’intervento statale non è sinonimo di inefficienza: anzi, fu spesso la condizione per superare l’arretratezza e promuovere innovazione. E anche il sistema di interazione tra politica (il welfare alla democristiana) e industria e finanza non toccò mai livelli tali da pregiudicare la forza del sistema.
La crisi giapponese che paralizzò il Paese per decenni non fu causata da un eccesso di intervento pubblico, ma dall’allentamento dei controlli sul credito e dalle decisioni politiche esterne, in particolare degli Stati Uniti. Gli Accordi del Plaza del 1985 — firmati per riequilibrare il deficit commerciale americano — portarono a una rivalutazione forzata dello yen (+51%) che mise in difficoltà le esportazioni nipponiche. Per evitare la recessione, Tokyo adottò una politica monetaria iper-espansiva: tassi quasi azzerati e liquidità a fiumi. Questa strategia, priva di freni adeguati, alimentò una bolla immobiliare e azionaria colossale. Quando la Banca del Giappone alzò i tassi per fermare la speculazione, la bolla scoppiò, e trascinò con sé interi decenni di crescita.
La storia del Giappone dimostra che non fu l’intervento pubblico a generare la crisi, ma la sua cattiva gestione e la subordinazione agli interessi americani. Il confronto con la più recente esperienza cinese è illuminante. Anche la Cina ha seguito un modello di capitalismo politico: intervento statale, banche pubbliche, pianificazione settoriale. Ma ha saputo evitare bolle di quelle dimensioni (e anche quando si sono presentate, come nel campo immobiliare), ha resistito alle pressioni per un riallineamento monetario rapido e traumatico come quello imposto al Giappone.
Il capitalismo politico cinese, limitandoci al solo aspetto economico e prescindendo dall’ideologia socialista, può essere visto come un’eredità aggiornata del modello giapponese ed europeo. Con una differenza cruciale: la Cina dispone di un’economia e di una forza demografica tali da rendere molto più difficile ogni tentativo americano di destabilizzazione. Oggi il mondo è multipolare, e blocchi come i BRICS e i BRICS+ offrono alternative che il Giappone non aveva negli anni Ottanta.
Il caso giapponese -e prima ancora quello italiano- insegna che non esiste un mercato perfetto capace di autoregolarsi: serve una regia pubblica che stimoli l’innovazione, prevenga le bolle speculative e gestisca l’integrazione globale in modo graduale e ponderato. Non basta più richiamare “la mano invisibile” o “la Teoria dello sgocciolamento”; quando la politica economica diventa ostaggio del liberismo dogmatico o delle rivalità geopolitiche, il prezzo da pagare può essere come minimo una generazione perduta.
La storia non si ripete mai uguale, ma spesso fa rima. Oggi come allora, i dogmi ideologici -la fede nel mercato assoluto o l’illusione di fermare l’ascesa altrui con pressioni valutarie- rischiano di produrre contraccolpi più gravi dei problemi che si vogliono risolvere. La differenza è che oggi il mondo non è più unipolare, e la Cina di oggi non è il Giappone del 1989.
Riflessione politica: l’eclissi delle alternative
Osservando la parabola giapponese, la deindustrializzazione italiana e i tentativi di contenere la crescita cinese, emerge un tratto comune che va oltre l’economia: l’affermazione del liberismo globale come unico orizzonte legittimo.
Negli anni Ottanta e Novanta, mentre Washington spingeva il Giappone a deregolare la finanza e mentre l’Unione Europea sanciva la libera circolazione dei capitali, gran parte dei partiti di sinistra abbandonava ogni prospettiva di trasformazione socialista o di economia democratica mista. Il crollo del blocco sovietico accelerò questa ritirata ideologica, ma il processo era iniziato già prima, con la convinzione che la globalizzazione capitalista fosse un destino irreversibile e che la politica potesse solo adattarsi.
La stagione del “New Labour” di Tony Blair, della “Terza Via” di Schröder e D’Alema, e delle riforme liberiste introdotte da governi “progressisti” segnò la rinuncia a difendere i meccanismi di programmazione economica, di intervento pubblico nei settori strategici e di tutela del lavoro organizzato, nei fatti un abbandono clamoroso del welfare che aveva rappresentato la peculiarità del capitalismo europeo. La sinistra accettò la finanziarizzazione come un fatto naturale, e le privatizzazioni furono presentate come strumenti di modernizzazione.
Questo mutamento culturale ha avuto effetti profondi: ha reso più vulnerabili i sistemi produttivi nazionali, ha spinto i governi a inseguire la competitività a qualsiasi costo e ha privato le società di strumenti di difesa di fronte alle crisi finanziarie e alle pressioni esterne. La lunga stagnazione del Giappone, il declino dell’industria italiana e le difficoltà di numerosi paesi periferici non furono solo il risultato di scelte tecniche sbagliate: furono anche la conseguenza di un pensiero politico che aveva smesso di immaginare alternative e che non aveva saputo affrancarsi dall’egemonia americana.
Oggi, il confronto con la Cina e le economie emergenti riapre interrogativi cruciali: è davvero inevitabile accettare il mercato assoluto come unico modello? Esiste uno spazio per un nuovo protagonismo pubblico che indirizzi lo sviluppo, protegga l’innovazione industriale e garantisca coesione sociale?
Se il “miracolo giapponese” e quello italiano furono possibili grazie a una regia pubblica e a investimenti di lungo termine, la lezione più attuale è proprio questa: senza un’alternativa al liberismo, rischiamo di restare ostaggi di crisi cicliche e di poteri finanziari incontrollabili. Riscoprire la legittimità di un’economia democratica potrebbe essere una delle sfide politiche più urgenti del nostro tempo.
Gian Luigi Betti 6-7-25