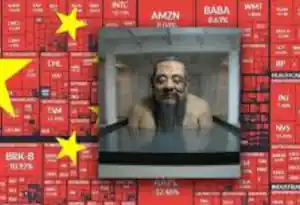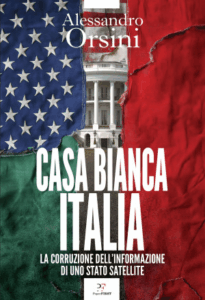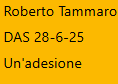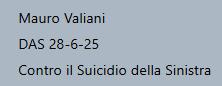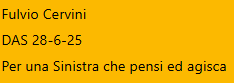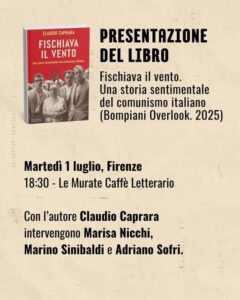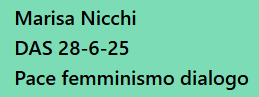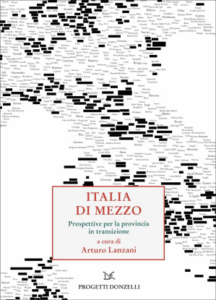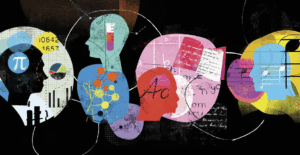L’eccedenza del capitalismo monopolistico e della rendita imperialista di Samir Amin MR 2012/7-8
Nota dell’editore
A partire dagli anni ’50 Samir Amin ha fornito una critica sistematica del sistema capitalista, a partire dal suo trattato di riferimento, L’accumulazione del capitale su scala mondiale (1957) e proseguendo fino alle sue importanti opere degli ultimi anni, in particolare La legge del valore mondiale (2010). Qui fornisce una spiegazione dell’importanza del Capitale Monopolistico di Baran e Sweezy per questa critica, mettendo in relazione il “surplus” (che egli identifica con tutte le entrate/uscite residue nel sistema dei conti nazionali al di là dei profitti e dei salari investiti) con la rendita imperiale. Per facilitare la comprensione della sua analisi, abbiamo inserito due note a piè di pagina che spiegano ulteriormente i due esempi numerici che fornisce.
il saggio di Samir Amin
Paul Baran e Paul Sweezy osarono, e poterono, continuare il lavoro iniziato da Marx. Partendo dall’osservazione che la tendenza intrinseca del capitalismo era quella di consentire aumenti del valore della forza-lavoro (salario) solo ad un tasso inferiore al tasso di aumento della produttività del lavoro sociale, essi dedussero che lo squilibrio risultante da questa distorsione avrebbe portato alla stagnazione in assenza di un’organizzazione sistematica dei modi per assorbire i profitti in eccesso derivanti da tale tendenza.
Questa osservazione è stata il punto di partenza per la definizione che hanno dato al nuovo concetto di “eccedenza”. Baran ha poi esteso l’analisi di Marx della dinamica dell’accumulazione del capitale nel secondo volume del Capitale, limitato rispettivamente ai due dipartimenti di produzione dei mezzi di produzione e dei beni di consumo, introducendo un dipartimento III che assorbe il surplus.
Ho sempre considerato questo tratto audace come un contributo cruciale all’utilizzazione creativa del pensiero di Marx. Baran e Sweezy osarono e poterono “partire da Marx” ma si rifiutarono di fermarsi, come tanti altri marxisti, all’esegesi dei suoi scritti.
Avendo, da parte mia, accettato completamente questo contributo cruciale di Baran e Sweezy, vorrei, in questa modesta offerta per il numero speciale che Monthly Review sta dedicando a onorare il loro lavoro, proporre una “metrica quantitativa” di quel surplus.
Metrica dell’eccedenza
L’eccedenza in questione è il risultato di una crescita della produttività del lavoro sociale superiore a quella del prezzo pagato per la forza-lavoro. Supponiamo, ad esempio, che il tasso di crescita della produttività del lavoro sociale sia di circa il 4,5 per cento all’anno, sufficiente a raddoppiare il prodotto netto in un periodo di circa quindici anni, corrispondente a una durata media presunta dei beni strumentali. Il Dipartimento I è costituito da beni di investimento che equivalgono ai profitti investiti e il Dipartimento II è costituito da beni salariali che equivalgono a salari. Per semplificare l’argomento assumeremo che per entrambi i Dipartimenti le composizioni organiche e i tassi di crescita della produttività del lavoro siano fissi. Permettere cambiamenti in questi parametri ci costringerebbe ad usare la notazione algebrica per il modello, cosa che potrebbe essere fatta facilmente, ma potrebbe renderlo più difficile da capire per i non matematici. Tenendo conto di queste complicazioni non cambierebbe nulla nelle conclusioni illustrate dal modello, a condizione che i salari reali aumentino meno del prodotto netto.
Supponiamo quindi che, nel lungo periodo, i salari reali crescano a un tasso di circa il 2,5 per cento all’anno, per un aumento del 40 per cento nell’arco di quindici anni. Concludiamo con cambiamenti nelle grandezze chiave del modello in conformità con il seguente schema (numeri approssimati):
Tabella 1. Accumulazione e Reparto III (Eccedenza)
| Anno | Ricavi netti | Dipartimento. Io | Dipartimento II | Dipartimento III |
| 1 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| 15 | 200 | 70 | 70 | 60 |
| 30 | 400 | 100 | 100 | 200 |
| 45 | 800 | 140 | 140 | 520 |
Alla fine di mezzo secolo di evoluzione regolare e continua del sistema, il surplus (che definisce la dimensione del Dipartimento III rispetto alle entrate nette, a sua volta la somma di salari, profitti reinvestiti e surplus) occupa i due terzi del prodotto netto (approssimativamente equivalente al PIL).*
Il cambiamento qui indicato è approssimativamente quello che in realtà è accaduto durante il ventesimo secolo nei centri “sviluppati” del capitalismo mondiale (la triade Stati Uniti/Europa/Giappone). Keynes aveva infatti notato che il capitalismo maturo era afflitto da una tendenza latente verso una stagnazione persistente. Ma non aveva spiegato questa tendenza, che gli avrebbe richiesto di prendere seriamente in considerazione la sostituzione del modello concorrenziale “classico” con il capitalismo monopolistico. La sua spiegazione rimaneva quindi tautologica: la stagnazione era il risultato della caduta – inspiegabile – dell’efficienza marginale del capitale o dei profitti attesi sui nuovi investimenti (al di sotto anche della più forte preferenza di liquidità). Al contrario, Baran e Sweezy hanno spiegato alla perfezione sia la tendenza alla stagnazione che i mezzi utilizzati per superarla. Hanno svelato i misteri del capitalismo contemporaneo.
Inizialmente, cioè fino alla guerra del 1914, il surplus ammontava in pratica solo a spese statali finanziate dalle tasse al massimo del 10-15 per cento del PIL. Si trattava di spese per il mantenimento delle spese sovrane (pubblica amministrazione, polizia, forze armate), legate alla gestione pubblica di alcuni servizi sociali (istruzione e sanità pubblica), e all’installazione di alcuni elementi infrastrutturali (strade e ponti, porti, linee ferroviarie).
L’analisi delle componenti corrispondenti al concetto di eccedenza mostra la diversità delle norme che ne disciplinano la gestione. Corrispondenti approssimativamente ai dipartimenti I e II di Marx nella contabilità nazionale sono i settori definiti rispettivamente come “primario” (produzione agricola e mineraria), “secondario” (manifatturiero) e una parte delle attività cosiddette “terziarie” che è difficile dedurre da statistiche che non sono state concepite a tale scopo, anche quando la definizione del loro status non è di per sé confusa. Da tenere a partecipare, indirettamente, alla produzione dei Dipartimenti I e II sono: trasporto di attrezzi, materie prime e prodotti finiti; commercio di tali prodotti; e il costo di gestione delle istituzioni finanziarie necessarie per servire i due Dipartimenti. Ciò che non deve essere considerato come elemento costitutivo diretto o indiretto della loro produzione, e quindi deve essere conteggiato come elemento di eccedenza, sono: l’amministrazione pubblica, le spese pubbliche e i trasferimenti (per l’istruzione, la sanità, la sicurezza sociale, le pensioni e le prestazioni di vecchiaia), i servizi (pubblicità) corrispondenti ai costi di vendita e i servizi personali pagati a carico del reddito (compresa l’abitazione).
Il fatto che i “servizi” di cui trattasi, raggruppati nei conti nazionali sotto il titolo “attività terziarie” (con la possibilità di distinguere tra loro un nuovo settore denominato “quaternario”), siano gestiti da soggetti pubblici o privati non li qualifica di per sé come appartenenti al dipartimento III (in prosieguo: l'”eccedenza”). Resta il fatto che il volume delle attività “terziarie” nei paesi sviluppati del centro (come anche in molti dei paesi periferici, anche se la questione – diversa – non ci riguarda in questa sede) è molto più grande di quello del settore primario e secondario. Inoltre, la somma delle tasse e dei contributi obbligatori in questi paesi ammonta da sola al 40 per cento o supera il loro PIL. I discorsi di alcuni ideologi fondamentalisti di destra che chiedono la “riduzione” di queste estrazioni fiscali sono puramente demagogici: il capitalismo non può più funzionare in nessun altro modo. In realtà, ogni eventuale diminuzione delle tasse pagate dai “ricchi” deve necessariamente essere compensata da una tassazione più pesante sui “poveri”!
Possiamo quindi stimare, senza rischio di errori gravi, che il “surplus” (Dipartimento III) rappresenta la metà del PIL o, in altri termini, è cresciuto dal 10 per cento del PIL nel XIX secolo al 50 per cento nel primo decennio del XXI secolo. Così, se – ai tempi di Marx – un’analisi dell’accumulazione limitata alla considerazione dei dipartimenti I e II aveva senso, non è più così. L’arricchimento del pensiero marxista da parte di Baran, Sweezy e Magdoff attraverso la loro presa in considerazione del Dipartimento III (e del concetto collegato di “eccedenza”, definito come l’abbiamo ricordato) è per questa ragione decisivo. Trovo deplorevole che la maggioranza degli analisti del marxismo contemporaneo ne dubiti ancora!
Ancora una volta, non “tutto” in questo surplus deve essere “condannato” come inutile o parassitario. Tutt’altro! Al contrario, la crescita di gran parte delle spese legate a questo Dipartimento III merita di essere sostenuta. In una fase più avanzata dello sviluppo della civiltà umana, la spesa per attività come l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la sicurezza sociale e la pensione – o anche altri “servizi” di socializzazione legati ad alternative strutturali democratiche alla strutturazione del mercato, come i trasporti pubblici e l’edilizia abitativa – assumerebbe un’importanza ancora maggiore. Al contrario, alcuni elementi costitutivi del Dipartimento III – come i “costi di vendita” che sono cresciuti in modo così favoloso durante il ventesimo secolo – sono evidentemente di natura parassitaria e sono stati ben presto visti come tali da alcuni economisti, come Joan Robinson, che sono stati minimizzati o denigrati dalla loro professione. Anche alcune spese pubbliche (armi) e alcune private (guardie di sicurezza, uffici legali) sono parassitarie. Una frazione del Dipartimento III, a dire il vero, è (o dovremmo dire era?) costituita da spese che avvantaggiano i lavoratori e integrano i loro salari (assistenza sanitaria e assicurazione contro la disoccupazione, pensioni). Allo stesso modo, questi benefici, conquistati dalle classi lavoratrici attraverso intense lotte, sono stati messi in discussione nel corso degli ultimi tre decenni, alcuni sono stati drasticamente ridotti, altri sono passati da una fornitura da parte di un’autorità pubblica basata sul principio della solidarietà sociale a una gestione privata presumibilmente “liberamente contrattata” sulla base dei “diritti individuali”. Questa tecnica di gestione, prevalente negli Stati Uniti e in espansione in Europa, apre aree supplementari, e molto redditizie, per l’investimento del surplus.
Resta il fatto che nel capitalismo tutti questi usi del PIL – “utili” o meno – assolvono alla stessa funzione: permettere all’accumulazione di continuare nonostante la crescente insufficienza dei redditi da lavoro. Inoltre, la battaglia permanente per il trasferimento di molti elementi fondamentali del Dipartimento III dalla gestione pubblica a quella privata apre opportunità supplementari per il capitale di “realizzare un profitto” (e quindi aumentare il volume del surplus!). L’assistenza medica privata ci dice che “se i malati devono essere curati, devono essere soprattutto redditizi (per le cliniche private, per i laboratori, per le case farmaceutiche e per gli assicuratori)”! La mia analisi del ruolo del Dipartimento III nell’assorbimento delle eccedenze si colloca nello spirito del lavoro pionieristico di Baran e Sweezy. La conclusione necessaria è che gran parte delle attività gestite in questi termini sono parassitarie e gonfiano il PIL, riducendo così drasticamente la sua importanza come indicatore della reale “ricchezza” di una società.
A ciò si contrappone la moda corrente di considerare la rapida crescita di questo Dipartimento come un segno della trasformazione del capitalismo, del suo passaggio dall'”era industriale” a una nuova fase, l'”economia della conoscenza”. L’incessante ricerca di realizzazione da parte del capitale riacquisterebbe così la sua legittimità. L’espressione “capitalismo della conoscenza” è di per sé un ossimoro. L’economia di domani, l’economia socialista, sarebbe infatti una “economia della conoscenza”: il capitalismo non potrà mai essere tale. Fantasticare che lo sviluppo delle forze produttive, da solo, costituisca – all’interno del capitalismo – l’economia di domani, come vorrebbero farci credere gli scritti di Antonio e dei suoi allievi, ha solo una validità apparente. In realtà, la realizzazione del capitale, necessariamente basata sull’oppressione del lavoro, spazza via l’aspetto progressivo di questo sviluppo. Questo annientamento è al centro dello sviluppo del Dipartimento III, destinato ad assorbire il surplus inseparabile dal capitalismo monopolistico.
Dobbiamo quindi evitare di confondere la realtà di oggi (il capitalismo) con una fantasia sul futuro (il socialismo). Il socialismo non è una forma più adeguata di capitalismo, che fa le stesse cose, ma solo meglio e con una distribuzione del reddito più equa. Il suo paradigma di governo – la socializzazione della gestione rispetto alla produzione diretta di valori d’uso – si accorda esattamente con un potente sviluppo di alcune delle spese che attualmente, sotto il capitalismo, partecipano alla sua funzione principale, l’assorbimento del surplus.
Ordine di grandezza della rendita imperialista
Nel suo assetto globalizzato, il capitalismo è inseparabile dallo sfruttamento imperialista delle sue periferie dominate da parte dei suoi centri dominanti. Sotto il capitalismo monopolistico questo sfruttamento prende la forma di rendite monopolistiche (nel linguaggio comune, i superprofitti delle multinazionali) che sono esse stesse in gran parte rendite imperialiste.
Nelle proposizioni che ho avanzato formulando i termini di una legge globalizzata del valore (vedi il mio La legge del valore mondiale), ho sottolineato tutta l’importanza di questa rendita. Vorrei qui dare un’idea della sua portata quantitativa nel capitalismo dei monopoli generalizzati e collegare i suoi effetti a quelli associati all’assorbimento eccedente.
L’ordine di grandezza della frazione quantificabile della rendita imperialista, risultato del differenziale dei prezzi delle forza-lavoro di uguale produttività, è ovviamente grande. Per dare qui un’idea di quest’ordine di grandezza, ipotizziamo una divisione del Prodotto Lordo mondiale nel rapporto di due terzi per i centri (20 per cento della popolazione mondiale) e un terzo per le periferie (80 per cento della popolazione). Ipotizziamo un tasso annuo di crescita del prodotto lordo del 4,5 per cento sia per i centri che per le periferie, e un tasso di crescita dei salari del 3,5 per cento per i centri, ma una stagnazione totale (crescita zero) per i salari periferici. Dopo quindici anni di sviluppo di questo modello arriveremmo ai risultati riassunti nella seguente tabella:
Tabella 2. L’eccedenza (Dipartimento III) e la rendita imperiale
| Centro | Periferie | Mondo | |
| Anno 1 | |||
| Prodotto Lordo | 66 | 33 | 100 |
| Salario | 33 | 17 | 50 |
| Profitti | 33 | 16 | 50 |
| Anno 15 | |||
| Prodotto Lordo | 132 | 68 | 200 |
| Salario | 56 | 17 | 73 |
| Profitti | 56 | 17 | 73 |
| Dipartimento III | 20 | — | 20 |
| Rendita imperialista | — | 34 | 34 |
Naturalmente, il volume di questa rendita imperialista, che sembra essere dell’ordine della metà del prodotto interno lordo delle periferie, o del 17 per cento del prodotto lordo mondiale e del 25 per cento del PIL dei centri, è parzialmente nascosto dai tassi di cambio. Si tratta qui di una realtà ben nota che introduce incertezza nei confronti internazionali: i confronti del valore del PIL devono essere effettuati in termini di tassi di cambio di mercato o in base a tassi di cambio che riflettono le parità di potere d’acquisto? Inoltre, l’affitto non viene trasferito come beneficio netto ai centri. Il fatto che le classi dominanti locali si aggrappino a una parte di esso è di per sé la condizione per il loro accordo di “giocare il gioco della globalizzazione”. Ma resta il fatto che i benefici materiali che si traggono da questa rendita, che vanno non solo a profitto del capitale che governa su scala mondiale, ma anche a profitto delle società opulente dei centri, sono più che considerevoli. †
Oltre ai vantaggi quantificabili legati alla differenziazione dei prezzi delle forze lavoro, ve ne sono altri, non quantificabili ma non per questo meno cruciali, basati sull’accesso esclusivo alle risorse materiali del pianeta, sui monopoli tecnologici e sul controllo del sistema finanziario globalizzato.
La quota di rendita imperialista trasferita dalle periferie ai centri accentua a sua volta lo squilibrio globale messo in evidenza da Baran e costituisce un ulteriore fattore di aumento del surplus da assorbire. Il contrasto che si osserva durante l’attuale fase della crisi, tra la debole crescita nei centri (Stati Uniti, Europa, Giappone) e la rapida crescita nei paesi in via di sviluppo della periferia, deve essere compreso solo nei termini di un’analisi globale che colleghi l’analisi di come viene assorbito il surplus all’analisi dell’estrazione della rendita imperialista.
Note dell’editore
- * Nel primo esempio numerico Amin assume che i prezzi siano proporzionali al valore del lavoro, cioè che la composizione organica del capitale sia la stessa in tutta l’economia e che anche i tassi di sfruttamento (profitti divisi per i salari) siano uguali. Se i mercati fossero competitivi, allora, secondo la teoria economica neoclassica standard, i salari aumenterebbero della stessa percentuale dell’aumento della produttività del lavoro. Nel suo esempio, i salari aumenterebbero del 4,5 per cento, lo stesso dell’aumento che ipotizza nella produttività. Tuttavia, egli propone, come fanno Baran e Sweezy (si veda il primo saggio di John Bellamy Foster per le ragioni per cui è così), che in condizioni di capitale monopolistico, i salari aumentano meno della produttività (astraendo dalla lotta sindacale che potrebbe forzare i salari verso l’alto). Ciò significa che nel tempo il divario tra la produzione totale di una società e i salari diventa sempre più grande. Questo è rappresentato dall’eccedenza nell’ultima colonna dell’esempio. Questo surplus deve essere assorbito da qualche parte nell’economia per evitare la stagnazione.
- † Nel secondo esempio numerico, Amin estende l’analisi del surplus all’economia globale. Qui il capitale monopolistico è in grado di muoversi in tutto il mondo e di usare il suo potere economico e politico per pagare ai lavoratori della periferia del capitalismo globale un salario considerevolmente inferiore a quello del centro, anche se la loro produttività è la stessa. Per chiarezza, Amin ipotizza che i salari nei paesi periferici non aumentino affatto. Ciò si traduce in un’enorme crescita del surplus nella periferia, gran parte del quale viene dirottato come rendita imperiale e finisce principalmente al centro attraverso le multinazionali. I super profitti (basati sul supersfruttamento del lavoro salariato) devono quindi essere assorbiti, rendendo la tendenza alla stagnazione analizzata da Baran e Sweezy potenzialmente più difficile da superare.
Nota
- ↩ Samir Amin, La legge del valore mondiale (New York: Monthly Review Press, 2010).