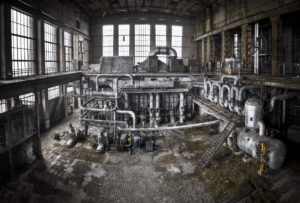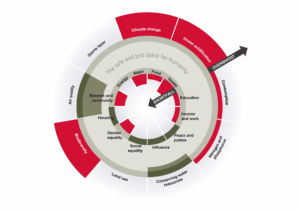La decolonizzazione e i suoi malcontenti di Pranay Somayajula MR/2025-01
Il saggio originale è in Monthly Review 2025/1
Bandiera zafferano in bicicletta durante il giorno dell’inaugurazione del tempio di Ram. (Lo sfondo recita The Great Bombay Circus.) 22 gennaio 2024. Di Ganesh Dhamodkar – Opera propria, CC BY 4.0, Link.
Abstract by Deepseek
Il saggio “Decolonizzazione e i suoi malcontenti” di Pranay Somayajula analizza criticamente l’appropriazione della retorica decoloniale da parte dei nazionalisti indù in India per giustificare politiche maggioritarie. L’inaugurazione del Ram Mandir ad Ayodhya nel gennaio 2024 — costruito sulle rovine di una moschea demolita — viene presentata dal partito al potere (BJP) come un trionfo della “decolonizzazione” contro il colonialismo britannico e secoli di dominio musulmano. L’articolo mostra come l’ideologia Hindutva riscriva la storia coloniale indiana per dipingere i musulmani come eterni stranieri, sfruttando la teoria decoloniale per mascherare un progetto etnonazionalista. Somayajula collega questo fenomeno a schemi globali (es. l’espulsione degli asiatici dall’Uganda sotto Idi Amin) e avverte: la decolonizzazione, per la sua malleabilità concettuale, rischia di essere strumentalizzata da forze reazionarie. La soluzione? Ripensare la decolonizzazione come lotta materiale, non come essenzialismo identitario.
Nota: Ho mantenuto i termini chiave (Hindutva, Ram Mandir, BJP) in originale per precisione, aggiungendo brevi spiegazioni dove necessario. Se vuoi una versione più “localizzata” (es. con “tempio di Ram” invece di Ram Mandir), fammelo sapere!
Scheda Sintetico-Analitica by Deepseek
1. Contesto e Tesi Principale
- Fenomeno analizzato: L’uso strumentale del linguaggio decoloniale da parte del movimento Hindutva in India.
- Esempio chiave: L’inaugurazione del Ram Mandir (2024) presentata come “decolonizzazione” dalla dominazione musulmana e britannica.
- Tesi: La retorica decoloniale, per la sua ambiguità concettuale, può essere piegata a fini reazionari, come dimostrano il nazionalismo indù e altri casi storici (Uganda, Myanmar).
2. Argomenti Centrali
- Riscrittura della storia coloniale:
- L’Hindutva retrodata la “colonizzazione” all’arrivo dei musulmani nell’VIII secolo, equiparando islam e imperialismo britannico.
- Conseguenza: I musulmani indiani (200 milioni) sono dipinti come invasori, legittimando discriminazioni.
- Decolonialità come arma culturale:
- Appropriazione di concetti accademici (es. “colonialità del potere” di Quijano/Mignolo) per promuovere un revival indù essenzialista.
- Esempio: Il libro India, That Is Bharat di J. Sai Deepak, che giustifica l’islamofobia come “decolonizzazione epistemologica”.
- Paralleli globali:
- Espulsione degli asiatici dall’Uganda (1972) sotto Amin, giustificata come “africanizzazione”.
- Avvertimenti di Fanon e Césaire sul rischio di una decolonizzazione ridotta a tribalismo.
3. Critica alla Sinistra Occidentale
- Astrattismo: La sinistra radicale ha svuotato il termine “decolonizzazione”, applicandolo a tutto (dai musei alle relazioni interpersonali) senza affrontare le strutture materiali del neocolonialismo.
- Rischio: Questo approccio facilita la cooptazione da parte di movimenti di destra, che usano la stessa retorica per scopi oppressivi.
4. Proposte Alternative
- Ritorno a Fanon: Decolonizzazione come progetto di liberazione materiale (ridistribuzione di ricchezza/potere), non solo culturale.
- Superare l’identitarismo: Rifiutare narrative essenzialiste di “indigenità” a favore di lotte trasversali (classe, genere).
5. Citazioni Chiave
- “L’Hindutva ha trasformato la decolonizzazione in uno strumento di supremazia etnoreligiosa” (p. 4).
- “La decolonialità accademica, con il suo focus sull’epistemologia, ignora le condizioni materiali che permettono ai fascismi di prosperare” (p. 12).
Tabella Riassuntiva
| Concetto | Uso nell’Hindutva | Critica dell’Autore |
|---|---|---|
| Decolonizzazione | Rivincita anti-musulmana | Deve essere legata a giustizia sociale |
| Storia coloniale | Inizia con l’Islam (VIII sec.) | Revisionismo per legittimare razzismo |
| Indigenità | Solo hindù di casta dominante | Esclude minoranze e subalterni |
Fonte: Adattato da Decolonization and Its Discontents (Pranay Somayajula, Culture Shock, 2025).
Formati aggiuntivi:
- Versione tweet: “Decolonization’ è la nuova arma dell’Hindutva: il Ram Mandir presentato come liberazione dai ‘colonizzatori’ musulmani. Ma Fanon ci aveva avvertiti: senza giustizia materiale, la retorica decoloniale diventa tribalismo. #DecolonizeTheLeft”
- Infografica suggerita: Mappa concettuale con collegamenti tra teoria decoloniale, Hindutva e casi storici (Uganda, Myanmar).
Pranay Somayajula è uno scrittore, organizzatore ed educatore politico indiano-americano, attualmente residente a Washington, DC. Scrive il blog Substack culture shock ed è il conduttore del podcast antimperialista Return to Bandung.
Traduzione di Decolonization and Its Discontents MR/2025-01
Nelle sue osservazioni alla cerimonia di consacrazione del Ram Mandir di nuova costruzione nel gennaio 2024 nella città di Ayodhya, nel nord dell’India, il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che “il 22 gennaio 2024 non è solo una data sul calendario. Segna l’inizio di una nuova era”.1 Per i compagni di viaggio di Modi nel movimento Hindutva (nazionalista indù), questa non era un’esagerazione. Come culmine di una campagna che ha costituito il fulcro della politica Hindutva per più di tre decenni, l’inaugurazione del Ram Mandir – costruito sul sito di una moschea del XVI secolo che è stata abbattuta da una folla indù nel 1992 – ha segnato per molti versi l’ascesa finale del movimento nazionalista indù verso uno status di egemonia quasi totale nella vita culturale e politica dell’India. In tutta l’India e nella diaspora, gli indù di destra hanno celebrato la consacrazione del Ram Mandir per aver portato il movimento un passo più vicino al suo obiettivo di ricostituire l’India come una maggioranza “Hindu Rashtra”, o nazione indù.
È importante, tuttavia, che la retorica della destra indù nelle settimane che hanno preceduto l’inaugurazione del tempio si sia estesa notevolmente oltre il mero trionfalismo, arrivando in molti casi a sostenere che il Ram Mandir simboleggiava un trionfo non solo della rinascita culturale, ma di niente di meno che la decolonizzazione dell’India stessa. Il 13 gennaio, poco più di una settimana prima della cerimonia di consacrazione del tempio, Balbir Punj, un importante giornalista indiano di destra ed ex parlamentare del Bharatiya Janata Party (BJP), ha pubblicato un libro intitolato Tryst with Ayodhya: Decolonisation of India.2 All’evento di lancio del libro, il cui titolo è un chiaro riferimento al discorso “Appuntamento con il destino” che Jawaharlal Nehru pronunciò alla vigilia dell’indipendenza indiana, il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh ha fatto eco a questo tema decolonizzante, affermando che “la ricostruzione del Ram Mandir di Ayodhya è il simbolo della decolonizzazione dell’India e della rinascita della cultura indiana”.3
L’uso del linguaggio decoloniale per esaltare l’insediamento del Ram Mandir è in linea con una più ampia strategia retorica dell’estrema destra nazionalista indù, che ha a lungo cercato di inquadrare le sue aspirazioni di stabilire un etnostato indù maggioritario come un progetto volto a liberare l’India – o “Bharat”, come la destra preferisce ora chiamarla – dalle vestigia del dominio coloniale.4 Ma mentre la comprensione tradizionale della storia coloniale dell’India colloca le sue origini nell’arrivo delle potenze europee nel subcontinente, identificando quindi il momento della decolonizzazione dell’India come il raggiungimento dell’indipendenza nazionale nel 1947, il movimento Hindutva ha una visione considerevolmente più lunga. Come scrive Sandhya Dhingra in un recente articolo per New Lines, l’estrema destra indù percepisce la colonizzazione dell’India come iniziata non con l’avvento dell’Impero britannico nel XVIII secolo, ma piuttosto con “l’arrivo di governanti musulmani o ‘invasori’ nel subcontinente nell’VIII secolo”, la cui conquista attraverso dinastie come i Khilji, si ritiene che i Tughlaq e i Moghul abbiano segnato l’inizio della colonizzazione dell’India da parte di potenze straniere.5
È a questa comprensione espansiva della storia che una figura come Modi si riferisce quando, ad esempio, dice al Congresso degli Stati Uniti che l’India ha goduto di “75 anni di libertà dopo mille anni di dominio straniero”.6 La proliferazione di questa storia revisionista, in particolare nel decennio successivo all’ascesa al potere del BJP, ha avuto enormi conseguenze. Nonostante abbiano radici nel subcontinente che risalgono a secoli fa e nonostante l’impatto incommensurabile che hanno avuto praticamente su ogni aspetto della cultura indiana, i musulmani dell’India sono stati rimodellati dalla versione Hindutva della storia come invasori stranieri allo stesso modo degli ex padroni britannici del paese. Attraverso questo progetto revisionista, l’ascesa del movimento suprematista indù è stato in grado di riformulare la sua sottomissione e privazione dei diritti dei musulmani indiani come un esempio di giustizia decoloniale piuttosto che di rozzo sciovinismo etnico. Allo stesso modo, il linguaggio della “decolonizzazione” ha informato gli sforzi al vetriolo dell’estrema destra indù per mascherare la violenza delle caste e ridurre le protezioni dell’azione affermativa per le comunità oppresse dalle caste, sulla base della falsa affermazione che il sistema delle caste è un “costrutto coloniale”.7
È facile liquidare questo fenomeno come un semplice esempio di come l’estrema destra si appropri cinicamente del linguaggio della politica liberatoria e lo distorce per servire un’agenda fascista. In effetti, questo è spesso il modo in cui l’abbraccio dell’Hindutva alla retorica decoloniale viene inquadrato sia nei commenti pubblici che in quelli accademici. Ma presentare la questione in termini così in bianco e nero è più che eccessivamente semplicistico, è attivamente dannoso per la nostra capacità di comprendere appieno perché questo particolare movimento sta usando questa particolare retorica in questo modo particolare, e perché è persino possibile che tale retorica venga mobilitata al servizio di una politica reazionaria di estrema destra in primo luogo. Infatti, lungi dall’essere un mero esempio di usurpazione in malafede, la riformulazione della decolonizzazione da parte dell’Hindutva come un progetto di supremazia etnoreligiosa piuttosto che come un progetto di liberazione collettiva riflette una contraddizione molto più fondamentale, insita nell’idea stessa di decolonizzazione, una contraddizione di cui i principali teorici del colonialismo e della resistenza anticoloniale del XX secolo erano acutamente consapevoli.
Scrivendo più di mezzo secolo fa, pensatori come Frantz Fanon e Aimé Césaire avvertivano che il progetto di decolonizzazione è intrinsecamente amorfo e adattabile, e richiede un’attenta vigilanza al fine di impedirne la cooptazione da parte di una “borghesia nazionale” i cui interessi di classe sono meglio serviti dalla promozione del tribalismo e della divisione etnica sotto le spoglie dell’autenticità indigenista. Questo punto è cruciale, perché significa che la “Hindutva-izzazione” della decolonizzazione in India non è solo un caso isolato, ma è di fatto un esempio emblematico di una questione molto più ampia, le cui implicazioni che fanno riflettere vanno ben oltre i confini di un singolo paese. Chiaramente, la decolonizzazione è un imperativo politico e morale che la sinistra non può permettersi di abbandonare, eppure dobbiamo fare i conti con il fatto che la sua malleabilità concettuale significa che è sempre stata suscettibile di interpretazioni sia liberatorie che reazionarie. Mentre riconoscere questa scomoda realtà può essere in contrasto con la tendenza della sinistra ad abbracciare acriticamente un’analisi superficiale della decolonizzazione come un bene universale e incondizionato, farlo è il primo passo cruciale verso lo sviluppo di una solida comprensione non solo di come siamo arrivati a questo punto, ma anche di dove andiamo da qui, e di cosa dobbiamo fare per rivendicare e rinvigorire una politica di decolonizzazione genuinamente radicale. aggiornato per il contesto sociale e politico in cui ci troviamo oggi.
Prima di poter iniziare a esaminare criticamente il concetto di “decolonizzazione”, tuttavia, dobbiamo prima essere chiari su cosa, esattamente, ci stiamo riferendo quando usiamo la parola. Il concetto di decolonizzazione, hanno scritto Jan C. Jansen e Jürgen Osterhammel nel loro libro del 2017 Decolonization: A Short History, ha avuto origine nel XX secolo come termine usato principalmente dagli imperi europei – vale a dire Gran Bretagna e Francia, “le ultime potenze coloniali rimaste di qualsiasi conseguenza” – per denotare una politica di amministrazione di fronte a “dinamiche storiche in corso, ” mentre i movimenti nazionalisti e le lotte di liberazione anticoloniali dilagavano nelle nazioni colonizzate dei continenti asiatico e africano. Quando l’influenza di questi imperi iniziò a diminuire e il sentimento nazionalista nelle colonie divenne più solido, gli amministratori coloniali iniziarono a spostare le loro priorità verso un trasferimento ordinato e prolungato del controllo politico alle élite dominanti native, nella speranza di coltivare strette relazioni con le loro future ex colonie. In altre parole, la “decolonizzazione” in questa formulazione imperiale è stata concepita non come un processo liberatorio, ma come un preludio necessario al neocolonialismo. “Con questo in mente”, concludevano Jansen e Osterhammel, “la decolonizzazione era intesa come una strategia e un obiettivo politico degli europei, un obiettivo da raggiungere con abilità e determinazione”.8
Naturalmente, contrariamente a quanto avevano sperato gli amministratori coloniali del XX secolo, il passaggio da colonia a post-colonia (nominale) fu tutt’altro che ordinato. In tutto il mondo colonizzato, dalla partizione dell’India alla guerra d’indipendenza algerina, la fine del dominio coloniale ha avuto luogo in un’esplosione orgiastica di violenza, lasciando dietro di sé una scia di bandiere nazionali che grondavano sangue anche se venivano issate per la prima volta. Tuttavia, il termine “decolonizzazione” ha mantenuto la sua attualità, in particolare per gli osservatori eruditi, come descrittore del fenomeno delle ex colonie che hanno raggiunto l’indipendenza. Lo storico imperiale Raymond F. Betts osserva che gli atti di una conferenza di Yale del 1965 sulla decolonizzazione iniziarono con l’affermazione che “la decolonizzazione è uno dei grandi temi della nostra epoca”, mentre “negli anni ’70, più di due dozzine di studi in inglese portavano la parola ‘decolonizzazione’ nel loro titolo”.9
L’idea della decolonizzazione è stata anche, naturalmente, ampiamente invocata da coloro che hanno fatto la decolonizzazione vera e propria, in particolare teorici anticoloniali e rivoluzionari come Fanon, lo psicologo e scrittore di origine martinicana che è stato il più importante ideologo e portavoce della lotta di liberazione algerina. Nella sua opera magna, I dannati della terra, Fanon descrisse notoriamente la decolonizzazione come “l’incontro tra due forze congenitamente antagoniste” di colonizzatore e colonizzato, un processo fondamentalmente violento, “[puzzante] di palle di cannone roventi e coltelli insanguinati”, la cui affermazione trasformativa dell’azione da parte dei colonizzati culmina nella “creazione di nuovi uomini”.10 La decolonizzazione, come concettualizzata da Fanon e dai suoi contemporanei nella lotta globale contro l’impero, era più di un semplice processo storico passivo; Era di per sé un progetto di rivolta cosciente e attivo, finalizzato nientemeno che a rifare il mondo da capo.
In ciascuno di questi casi, il termine “decolonizzazione” è usato in un modo o nell’altro per denotare un fenomeno politico concretamente definito; vale a dire, la fine del dominio coloniale e il raggiungimento dell’indipendenza formale da parte delle ex colonie. Che sia usato in modo descrittivo o prescrittivo, la “decolonizzazione” in questo contesto è un concetto che è decisamente radicato nelle effettive circostanze politiche, economiche e sociali del paese in fase di decolonizzazione. (Dico “decolonizzare il paese” perché questo concetto di decolonizzazione è invariabilmente inquadrato più o meno esclusivamente in termini di stati-nazione e sovranità nazionale). Tuttavia, guardando al modo in cui la decolonizzazione è comunemente invocata oggi, è probabile notare che a un certo punto nell’ultimo mezzo secolo o giù di lì, la portata del concetto sembra essersi ampliata. Da un’attenzione più limitata alle questioni materiali della sovranità politica ed economica, la decolonizzazione è arrivata a comprendere una gamma molto più ampia di argomenti, come evidenziato dalla proliferazione in molti circoli di attivisti occidentali di appelli a “decolonizzare” tutto, dalla medicina all’istruzione alle relazioni interpersonali.11
In molti modi, questa tendenza all’espansione e all’astrazione riflette l’ampia influenza politica e retorica della teoria decoloniale, una scuola di pensiero emersa negli anni ’90 dal lavoro di studiosi latinoamericani come Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Come quadro, la teoria decoloniale (o “decolonialità”, come è spesso conosciuta) enfatizza le dimensioni culturali ed epistemologiche della dominazione coloniale, evidenziando come, come ha detto Quijano, “la cultura europea o occidentale ha imposto la sua immagine paradigmatica e i suoi principali elementi cognitivi come norma di orientamento su tutto lo sviluppo culturale” nel mondo colonizzato, un progetto di “eurocentrificazione” che, I teorici decoloniali sostengono che continua a plasmare le società colonizzate molto tempo dopo il raggiungimento dell’indipendenza politica formale.12
Al centro del quadro decoloniale c’è l’idea di “colonialità”, una critica della modernità che enfatizza il ruolo costitutivo del colonialismo nel plasmarla (a tal fine, i teorici della decolonialità spesso scrivono “modernità” e “colonialità” come un unico termine: modernità/colonialità). La colonialità, in questo quadro, è sostenuta dalla “matrice coloniale del potere”, che comprende “quattro domini interconnessi: il controllo dell’economia, dell’autorità, del genere e della sessualità, e della conoscenza e della soggettività”.13 È importante sottolineare che ciò che distingue questo quadro teorico dal progetto politico ed economico di decolonizzazione descritto, ad esempio, da Fanon è la sua espansione nei regni della cultura e della conoscenza. Come scrivono Mignolo e la sua coautrice Catherine Walsh, l'”orizzonte” della decolonialità non si limita “all’indipendenza politica degli stati-nazione” o al “confronto con il capitalismo e l’Occidente”, ma piuttosto alle “abitudini che la modernità/colonialità ha impiantato in tutti noi; con il modo in cui la modernità/colonialità ha lavorato e continua a lavorare per negare, sconfessare, distorcere e negare le conoscenze, le soggettività, i sensi del mondo e le visioni della vita”.14 Il progetto di decolonialità sottolinea quindi la necessità di “sganciarsi” da questi sistemi eurocentrici di conoscenza e di potere, un compito il cui obiettivo è “non più quello di ‘impadronirsi dello Stato’ ma di impegnarsi in una ricostituzione epistemica e soggettiva”, segnando così un esplicito allontanamento dal concreto fondamento politico-economico delle lotte di liberazione nazionale del XX secolo.15
Sebbene la teoria decoloniale abbia avuto origine nell’accademia, la sua influenza si è estesa ben oltre i cancelli del campus. Echi di ciò possono essere osservati nella versione della decolonizzazione che è diventata popolare tra la sinistra occidentale contemporanea, in particolare tra la sinistra americana, e in particolare dopo le rivolte di Black Lives Matter dell’estate 2020, quando gli appelli a “decolonizzare tutto” hanno iniziato a proliferare insieme a condanne più ampie della supremazia bianca. Tra gli obiettivi più visibili di questi appelli c’erano istituzioni intellettuali e culturali – università, musei, archivi e simili – che sono state messe sotto pressione per “decolonizzare” attraverso gesti come il riconoscimento della terra, la ridenominazione degli edifici, il rimpatrio dei manufatti saccheggiati e la rielaborazione dei curricula per “centrare” in modo più adeguato le voci nere e indigene.
Questa tendenza potrebbe essere osservata su entrambe le sponde dell’Atlantico, poiché gli appelli alla “decolonizzazione” hanno costretto le istituzioni europee a fare i conti con la loro complicità negli imperi del XIX e XX secolo, le istituzioni nordamericane a fare i conti con la loro complicità nella violenza coloniale contro i popoli indigeni del continente e le istituzioni su entrambe le sponde dell’oceano a fare i conti con la loro complicità nella tratta transatlantica degli schiavi. Concentrando la sua critica sulle istituzioni che fungono da pilastri della produzione di conoscenza occidentale, la versione della decolonizzazione che ha preso piede nella sinistra contemporanea nel 2020 costituisce per molti versi un atto d’accusa contro la stessa epistemologia occidentale. Qui, l’influenza della teoria decoloniale non è difficile da discernere. Implicita in questa critica delle forme dominanti di produzione di conoscenza c’è un appello a elevare al loro posto i modi indigeni di conoscere e di essere che sono stati soppressi dagli stessi processi di violenza coloniale e di espropriazione di cui queste istituzioni erano (e sono) complici.
L’influenza della teoria decoloniale nel mondo reale, tuttavia, non si limita alla sinistra. Al contrario, la versione della decolonizzazione sposata dal movimento Hindutva riflette anche questa scuola di pensiero, per molti versi anche più esplicitamente della sua controparte di sinistra. Nei loro appelli per un ritorno a un’immaginaria “età dell’oro” di gloria della civiltà indù, i leader dell’Hindutva invocano spesso il linguaggio del superamento di una “mentalità colonizzata” e del rilancio della cosiddetta “coscienza indiana” – la serie di filosofie, cosmologie ed epistemologie “indigene” (leggi: indù di casta dominante) che i suoi sostenitori sostengono siano state soppresse da secoli di colonizzazione islamica e britannica. Nella sua forma più esagerata, questo atavismo epistemico può essere osservato nei meme virali, così popolari nei circoli di destra di WhatsApp, che affermano che gli antichi indiani hanno inventato di tutto, dagli aerei alle armi nucleari a Internet.16
Chiaramente, sarebbe un’esagerazione grossolana affermare che la teoria decoloniale sia in qualche modo responsabile dell’ascesa dell’Hindutva, o che gli studiosi e gli attivisti occidentali che abbracciano questo quadro teorico stiano contribuendo in modo significativo alla legittimazione dello sciovinismo di estrema destra. Eppure, l’abbraccio del pensiero decoloniale da parte del movimento nazionalista indù indica che, almeno nella sua forma più cruda, la logica della decolonialità – una logica che offusca i confini già oscuri tra “straniero”, “occidentale”, “moderno” e “coloniale” – può essere facilmente invocata dagli attori di destra per giustificare una politica di sciovinismo etnonazionalista in cui certi gruppi sono considerati soggetti decoloniali autenticamente indigeni la cui rinascita culturale e l’emancipazione richiedono la violenza emarginazione di altre comunità.
C’è, naturalmente, un’importante distinzione da fare tra le disparate invocazioni della decolonialità da parte degli estremisti indù e della sinistra nordamericana, vale a dire che in Nord America il pensiero e le tradizioni indigene sono stati violentemente soppressi dal colonialismo di insediamento, mentre in India gli indù sono stati a lungo e rimangono una maggioranza sostanziale che occupa una chiara posizione di egemonia culturale. Tuttavia, questa realtà non ha impedito ai nazionalisti indù di abbracciare il quadro decoloniale al fine di costruire e trasformare in un’arma una narrativa perniciosa del vittimismo indù. Nel 2021, ad esempio, l’avvocato di destra e ideologo dell’Hindutva J. Sai Deepak ha pubblicato un libro intitolato India, That Is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution. Lo scopo del libro, ha scritto Deepak, è quello di “[esplorare] l’influenza della coscienza coloniale/colonialità europea, in particolare le sue radici religiose e razziali, su Bharat come Stato successore della civiltà indiana”. In tutto il libro, Deepak abbraccia esplicitamente il quadro teorico della decolonialità per legittimare la storia revisionista dell’Hindutva e il virulento fanatismo anti-musulmano, invocando il tropo del “colonialismo di insediamento mediorientale” e sostenendo che gli “invasori musulmani” sono arrivati in India non solo per “cantare il loro inno di odio e tornare a bruciare alcuni templi lungo la strada”, ma anche per “piantare il seme dell’Islam” la cui “crescita è così fitta nell’India settentrionale che i resti dell’indù e la cultura buddista sono [ora] solo arbusti”.17
In una feroce recensione del lavoro di Deepak, lo storico sudafricano Anandaroop Sen scrive che “la decolonialità in questo libro è una tattica della politica violenta etnica maggioritaria per apparire come una vittima specifica del passato coloniale”.18 Che l’argomentazione di Deepak cerchi di strumentalizzare la decolonialità al servizio di un’agenda essenzialmente neofascista sembra certamente ovvio, eppure, al momento della sua uscita, il libro ha ricevuto un forte sostegno da uno dei principali esponenti della teoria decoloniale. In un episodio che può essere descritto solo come un’auto-parodia decoloniale, la sovraccoperta del libro presentava una recensione entusiastica nientemeno che dello stesso Mignolo, che elogiava Deepak per “[costruire] un forte argomento decoloniale che si sgancia dalla moderna ortodossia occidentale dell’aut-aut, e [propone] invece la logica decoloniale del non-o/né”.19 Non sorprende che, dopo aver affrontato un significativo contraccolpo da parte di attivisti e accademici, Mignolo alla fine abbia ritirato il suo sostegno al libro di Deepak.
Questo episodio di per sé non è una prova sufficiente di una connessione diretta tra la teoria decoloniale e il fascismo Hindutva. Eppure, come evidenziato in precedenza, le logiche decoloniali di “sganciamento” dall’epistemologia occidentale e di rafforzamento di una “coscienza indigena indiana” che si suppone sia stata soppressa da secoli di colonizzazione europea e islamica sono onnipresenti nella retorica e nelle attività del movimento Hindutva contemporaneo. Lo stesso Deepak è diventato una sorta di celebrità intellettuale tra i sostenitori dell’Hindutva: attualmente raggiunge un pubblico di oltre 720.000 follower su X (ex Twitter) e le clip dei suoi discorsi e interviste accumulano regolarmente centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Quando nel marzo 2024 Deepak è stato invitato a parlare all’Università della California, Berkeley, dalla sezione di Berkeley dell’Hindu YUVA (acronimo di “Gioventù, Unità, Virtù e Azione”), il braccio studentesco dell’Hindu Swayamsevak Sangh (a sua volta l’ala statunitense dell’organizzazione paramilitare Rashtriya Swayamsevak Sangh con sede in India), è stato introdotto con un riconoscimento della terra e una preghiera indigena da un attivista nativo americano.20
Forse, quindi, la debacle Mignolo-Deepak non è stata solo un mero malinteso, ma piuttosto il riflesso di un problema molto più ampio e profondo con l’intrinseca ampiezza e malleabilità del quadro decoloniale. La recensione di Sen di India, That Is Bharat si conclude con una “domanda incombente”: “queste mutazioni”, si chiede, “sono la svolta della destra indiana sulla politica liberatoria del decolonialismo, o fanno parte dell’architettura interna di questo movimento intellettuale?”21 Questa riflessione è ripresa più concretamente dalla studiosa postcoloniale Priyamvada Gopal, che ha sostenuto in un’intervista con Jamhoor che forse c’è “qualcosa nell’idea di decoloniale – tirare fuori un altro corpo di conoscenze, rivolgersi al pre-coloniale, tirare fuori qualcosa che non è occidentale e sostituire l’occidentale con esso – questa è una ricetta già pronta per quello che è successo [tra Mignolo e Deepak]. che è l’incapacità di mettere in discussione cosa siano queste cosiddette epistemologie non occidentali e quale sia il loro contenuto”.22
Il punto di Gopal qui è cruciale. È un progetto facile, e certamente attraente, diventare poetici sulla necessità di “scollegare” o “decolonizzare” evitando le trappole della modernità occidentale a favore di modi indigeni di pensare e di essere. Così facendo, tuttavia, si solleva la difficile (e troppo spesso senza risposta) questione di quali modi di pensare e di essere siano considerati sufficientemente “indigeni” e quindi i “veri” soggetti della decolonizzazione. Per quelli di noi che sono attivi nei circoli accademici e attivisti occidentali che hanno abbracciato con tanto entusiasmo questa comprensione espansiva della politica decoloniale, spetta a noi affrontare questa difficoltà a testa alta, articolando un’analisi alternativa della decolonizzazione che rifiuti esplicitamente lo sciovinismo di estrema destra e si basi su condizioni politiche ed economiche materiali, qualcosa che i quadri accademici tradizionali della decolonialità non hanno costantemente fatto.
Dopo tutto, non esiste una società veramente omogenea, men che meno società colonizzate ed ex colonizzate, in cui i confini e le divisioni amministrative sono stati in molti casi tracciati dalle potenze coloniali senza alcun riguardo per le popolazioni locali che le circondavano. Praticamente ogni stato-nazione del mondo è composto da una vasta gamma di clan, tribù, comunità religiose e gruppi etnici, ognuno con la propria identità, storia e cultura di gruppo. Un progetto decoloniale che non tiene conto di questa diversità e si basa invece su concetti vaghi e mal definiti di indigenità “autentica” può, nelle mani sbagliate, trasformarsi rapidamente in una politica ristretta di nativismo maggioritario, in cui le minoranze e gli altri gruppi subalterni sono essi stessi considerati come estranei coloniali, piuttosto che come soggetti di decolonizzazione a pieno titolo.
L’India non è l’unico caso di logiche di decolonizzazione invocate dagli ultranazionalisti per giustificare l’esclusione violenta delle minoranze nei paesi precedentemente colonizzati, e mentre la versione della decolonizzazione invocata dagli estremisti dell’Hindutva riflette la chiara influenza del quadro decoloniale, uno sguardo alla documentazione storica postcoloniale rivela rapidamente che questo fenomeno precede di molto la divulgazione delle idee sviluppate da personaggi del calibro di Quijano e Mignolo.
Per un esempio di decolonizzazione strumentalizzata per fini di esclusione, possiamo rivolgerci all’Uganda, dove nell’agosto del 1972 l’allora presidente Idi Amin ordinò l’improvvisa espulsione della considerevole minoranza dell’Asia meridionale del paese. Questa espulsione è stata il prodotto di risentimenti profondi e di dinamiche politiche che covavano da decenni. Durante l’era del dominio britannico in Africa orientale, gli amministratori coloniali portarono migliaia di persone dall’India britannica in Uganda per servire come operai e amministratori di medio livello (una politica replicata in altre colonie britanniche, dal Kenya al Sud Africa). Conosciuti semplicemente come “asiatici”, questi migranti occupavano una posizione intermedia tra le élite coloniali e i nativi ugandesi nella gerarchia sociale, politica ed economica della colonia e ricevevano generalmente un trattamento preferenziale dall’amministrazione coloniale rispetto ai “nativi”. Negli anni successivi all’indipendenza dell’Uganda nel 1962, gli asiatici ugandesi arrivarono a dominare la vita commerciale del paese, portando a un diffuso risentimento e a una serie di politiche attuate sia da Amin che dal suo predecessore, Milton Obote, che presero di mira la minoranza asiatica in vari modi, culminando infine nella loro espulsione nel 1972.
È importante sottolineare che l’espulsione degli asiatici ugandesi è stata giustificata da una logica nativista che ha cercato di dipingere la minoranza asiatica del paese non come connazionali che avevano condiviso l’esperienza della sottomissione coloniale del popolo ugandese, ma piuttosto come reliquie parassitarie del passato coloniale. Amin si riferì ripetutamente agli asiatici ugandesi nei suoi discorsi come “succhiasangue” e dichiarò che la sua “politica deliberata” nell’espellerli era quella di “trasferire il controllo economico dell’Uganda nelle mani degli ugandesi, per la prima volta nella storia del nostro paese”.23 L’espulsione è stata effettuata nell’ambito di un più ampio progetto di cosiddetta africanizzazione. Si trattava di una politica di azione affermativa che, come Mahmood Mamdani (egli stesso un indiano ugandese espulso da Amin nel 1972) ha sottolineato, beneficiava solo una “minoranza privilegiata” di afrougandesi, nonostante fosse nominalmente destinata a fornire un risarcimento a coloro che avevano subito il peso dell’oppressione coloniale. Questa politica fu invocata dal governo di Amin “come antidoto alle pressioni popolari per la democratizzazione”.24 Come i Tutsi in Ruanda, gli asiatici ugandesi costituivano una “razza sottomessa” che aveva ricevuto un trattamento relativamente preferenziale sotto il dominio coloniale rispetto alla popolazione apparentemente “nativa”. Ciò significava che, all’indomani dell’indipendenza, la loro continua presenza nel paese era vista dai nativisti maggioritari come un residuo indesiderato della dominazione straniera, e la cui rimozione sarebbe stata una condizione necessaria per il completamento del processo di decolonizzazione.
Per tutto il ventesimo secolo e fino al nostro, questo fenomeno delle “razze assoggettate” che affrontano l’esclusione violenta durante il processo e le conseguenze della decolonizzazione si è ripetuto più e più volte in tutto il mondo precedentemente colonizzato, dal massacro degli arabi durante la rivoluzione di Zanzibar alla persecuzione e al genocidio decennale dei tamil dello Sri Lanka fino al genocidio in corso dei Rohingya in Myanmar. Mentre il caso dell’Hindutva esemplifica i modi in cui la logica decoloniale può facilmente prestarsi a una politica di nativismo escludente, l’abbondanza di esempi come questi – molti dei quali precedono di molto l’emergere della teoria decoloniale come scuola di pensiero distinta – significa che c’è chiaramente di più nella storia di un mero problema concettuale con un qualsiasi quadro accademico o teorico.
In realtà, ciò che questa storia a scacchi rivela è una contraddizione fondamentale alla base del progetto stesso di decolonizzazione: vale a dire, la contraddizione tra la chiara necessità di scrollarsi di dosso le vestigia della dominazione coloniale da un lato, e i modi in cui questo progetto può essere opportunisticamente utilizzato come arma per promuovere una politica di divisione tribale e di nativismo maggioritario dall’altro. I principali teorici della decolonizzazione e della resistenza anticoloniale del XX secolo erano ben consapevoli di questa contraddizione e hanno messo in guardia con forza contro i pericoli di permettere che la decolonizzazione venga utilizzata come arma in questo modo. Chiaramente, la strumentalizzazione della decolonizzazione da parte di cattivi attori non è in alcun modo un motivo per abbandonarla del tutto, ma se vogliamo rivendicare la decolonizzazione come un progetto liberatorio piuttosto che reazionario, è imperativo prendere sul serio questi avvertimenti.
“La coscienza nazionale”, scrisse Fanon ne I dannati della terra, “non è altro che un guscio grezzo, vuoto, fragile. Le crepe in esso spiegano quanto sia facile per i giovani paesi indipendenti passare da nazione a gruppo etnico e da stato a tribù”. Il processo di decolonizzazione, secondo Fanon, offre alla “borghesia nazionale” di un paese di recente indipendenza l’occasione perfetta per ammantare i propri interessi di classe nel linguaggio del nazionalismo, incoraggiando il piccolo sciovinismo e promuovendo politiche di “africanizzazione” che, nonostante le loro promesse di emancipazione indigena, in pratica servono solo a incanalare ricchezza e potere nelle mani di un’élite indigena privilegiata. Il tutto distogliendo l’attenzione dal fatto che questa élite ha in effetti preso il posto degli ex colonizzatori del paese. Nonostante l’esperienza condivisa dell’oppressione coloniale e della resistenza anticoloniale prima dell’indipendenza, le minoranze sono diffamate come stranieri traditori e stranieri indesiderati, e la loro presenza nel paese è inquadrata come una minaccia agli interessi dei “veri” membri della comunità nazionale. “Di conseguenza”, avvertiva Fanon, “ovunque la meschinità della borghesia nazionale e la nebulosità delle sue posizioni ideologiche non sono state in grado di illuminare il popolo nel suo insieme… C’è un ritorno al tribalismo, e noi guardiamo con il cuore furioso il trionfo delle tensioni etniche”.25
Non sorprende che l’asprazione di Fanon della borghesia nazionale per la sua promozione dello sciovinismo sotto le spoglie dell’orgoglio nazionalista sia accompagnata da un avvertimento che questo ripiegamento nel nativismo deve essere contrastato a tutti i costi se il progetto di decolonizzazione deve avere successo. “Se vogliamo davvero salvaguardare i nostri paesi dalla regressione, dalla paralisi o dal collasso”, ha spiegato, “dobbiamo passare rapidamente da una coscienza nazionale a una coscienza sociale e politica”. Questo processo comporta non solo l’adozione di un ethos umanista che rifugga le divisioni tribali, ma anche lo sviluppo di un programma politico ed economico concreto che affronti le condizioni materiali della società in via di decolonizzazione e preveda la radicale redistribuzione della ricchezza e del potere sociale. Allo stesso modo, Fanon ha messo in guardia contro qualsiasi politica culturalista di autenticità che si basi su una concezione calcificata della cultura nazionale e richieda un ritorno a un passato precoloniale idealizzato. “Non è sufficiente”, ha scritto, “riunirsi con il popolo in un passato in cui non esiste più”. Invece, “dobbiamo lavorare e lottare al passo con il popolo per plasmare il futuro e preparare il terreno dove stanno già germogliando germogli vigorosi”.26
In altre parole, mentre c’è indubbiamente un elemento culturale nella concezione di Fanon della decolonizzazione, ciò che ciò comporta realmente è la formazione di una nuova cultura nazionale, forgiata nel fuoco della resistenza anticoloniale e fondata su un ethos di umanesimo rivoluzionario – non un atavico ritiro dalla modernità alla ricerca di un’immaginaria età dell’oro passata. Echi di ciò si possono trovare nel pensiero di una delle più grandi influenze di Fanon, Césaire, il poeta e teorico martinicano. Nel suo Discorso sul colonialismo del 1950, ad esempio, Césaire lamentava le “società distrutte dall’imperialismo” mentre rifiutava categoricamente qualsiasi idea di un ritorno al passato precoloniale. «Cerco invano», scriveva Césaire, «il posto… dove ho mai predicato un ritorno di qualsiasi tipo; dove ho mai affermato che ci potrebbe essere un ritorno“.27
Come sottolinea lo storico Robin D. G. Kelley nell’introduzione all’edizione del Discorso sul Colonialismo della Monthly Review Press, “sia Fanon che Césaire avvertono il mondo di colore di non seguire le orme dell’Europa, e di non tornare alla via antica, ma di ritagliarsi una nuova direzione del tutto”.28 Per entrambe le figure – e per Fanon in particolare – la decolonizzazione è allo stesso tempo un processo necessario e irto, che richiede cura e vigilanza per evitare che si trasformi in un veicolo di nostalgia stagnante e in un campo di battaglia per odi tribalistici. Gli scritti di entrambi i pensatori rivelano la preveggenza che fa riflettere con cui hanno riconosciuto i pericoli e le contraddizioni di glorificare acriticamente il passato precoloniale e abbracciare una coscienza nazionale che si basa su concezioni ristrette ed essenzializzate di chi è “veramente” indigeno del paese in via di decolonizzazione.
Allo stesso modo, il teorico e rivoluzionario della Bissau-Guinea e Capo Verde Amílcar Cabral sosteneva nel suo fondamentale saggio del 1974, “Liberazione nazionale e cultura”, che per quanto dannosa sia stata “la denigrazione dei valori culturali dei popoli africani basata su pregiudizi razzialisti”, sarebbe altrettanto dannoso per la lotta di liberazione nazionale impegnarsi in “cieca accettazione dei valori culturali senza considerare gli aspetti negativi, reazionario o regressivo [aspetti] che ha o può avere”.29 Sebbene Cabral abbia notoriamente descritto la rinascita culturale e la resistenza come un “ritorno alla fonte”, tuttavia chiarisce in questo saggio che la lotta di liberazione nazionale, nei suoi sforzi per promuovere e nutrire la cultura indigena, non può permettersi “confusione tra ciò che è l’espressione di una realtà storica oggettiva e materiale e ciò che sembra essere un’invenzione della mente”.30
Quelli di noi che si occupano di questioni di impero e decolonizzazione ai giorni nostri farebbero bene a prestare attenzione a questi avvertimenti. La decolonizzazione, come ha sottolineato Fanon ne I dannati della terra, non è un evento una tantum che può essere “compiuto con un colpo di bacchetta magica”, ma piuttosto un “processo storico” che rimane, per ora, incompleto.31 Chiaramente, il ruolo costitutivo che il colonialismo ha svolto (e continua a svolgere) nel plasmare quasi ogni aspetto del nostro mondo significa che c’è ancora un urgente bisogno di una politica radicale e sostanziale di decolonizzazione, sia nelle società coloniali come gli Stati Uniti e il Canada, dove l’espropriazione violenta e lo spostamento delle comunità indigene è un processo continuo; nelle ex potenze imperiali come la Gran Bretagna e la Francia, la cui ricchezza è stata costruita con le ricchezze saccheggiate del mondo colonizzato; o negli innumerevoli paesi precedentemente colonizzati in Asia, Africa e America Latina i cui abitanti devono ancora essere veramente liberati dal giogo dello sfruttamento neocoloniale.
Tuttavia, il raggiungimento dell'”indipendenza della bandiera” da parte della maggior parte delle colonie europee ha fatto sì che gli orizzonti della “decolonizzazione” come richiesta politica si siano ampliati considerevolmente all’indomani delle lotte di liberazione nazionale che hanno spazzato il mondo colonizzato tra la metà e la fine del XX secolo. Il problema, tuttavia, è che nella misura in cui “decolonizzazione” esiste ancora come termine nel lessico della sinistra contemporanea, questi orizzonti sembrano essersi allargati nella direzione sbagliata. Piuttosto che cambiare marcia per concentrarsi sulle dimensioni politiche ed economiche concrete del neocolonialismo (in senso lato) che continuano ad affliggerci oggi, la sinistra occidentale mainstream ha invece abbracciato una politica di decolonizzazione declinata con il linguaggio della decolonialità, che si definisce in termini sempre più amorfi e astratti, al punto che il termine stesso “decolonizzazione, Come è comunemente invocato nel discorso di sinistra, sembra che in realtà sia arrivato a denotare tutto tranne che rovesciare le strutture materiali dell’attuale violenza coloniale e dello sfruttamento.
Questo approccio è pericoloso per due motivi. In primo luogo, distoglie l’attenzione dall’urgente progetto di resistere a queste strutture in tutte le loro varie manifestazioni concrete, agendo erroneamente come se le dimensioni materiali del colonialismo si fossero semplicemente dissolte quando l’era del dominio coloniale formale è giunta al termine. In secondo luogo, e forse più importante, trattare con tali astrazioni comporta un rischio maggiore – come l’esempio dell’Hindutva rende chiaro – di esacerbare le stesse contraddizioni da cui Fanon e i suoi contemporanei ci hanno messo in guardia, fornendo così una copertura per l’emergere di un etnonazionalismo violento e tribale che si nasconde nella retorica dell’indigenità e della giustizia decoloniale.
La sinistra antimperialista contemporanea ha l’urgente responsabilità collettiva di resistere a questa emersione ovunque si verifichi e di fare tutto il possibile per rivendicare la decolonizzazione dalle grinfie dell’estrema destra nativista. Ciò di cui abbiamo bisogno, quindi, è un ritorno a una comprensione materialmente fondata dell’impero e della resistenza, che tratti il colonialismo prima di tutto come una questione di sfruttamento politico ed economico, e la decolonizzazione come una questione di annullamento dell’espropriazione e di ridistribuzione della ricchezza e del potere in termini concreti e materiali. Gli aspetti culturali ed epistemologici della decolonizzazione possono e devono svolgere un ruolo in questo progetto, ma, in parole povere, ci sono troppe preoccupazioni più urgenti perché possano essere al centro della scena. Qualsiasi versione della decolonizzazione che inverta questa formula, dando maggiore importanza all’astratto che al materiale, è una “decolonizzazione” che ha smarrito la sua strada.
Note
- ↩ Narendra Modi, “‘Ram non è una controversia, Ram è una soluzione’: testo completo del discorso del Primo Ministro Modi alla consacrazione di Ayodhya”, The Print, 23 gennaio 2024.
- ↩ “‘Appuntamento con Ayodhya: Decolonizzazione dell’India’ di Balbir Punj si prepara a svelare i fili storici il 13 gennaio”, Organizzatore, 11 gennaio 2024, organiser.org.
- ↩ “‘Ram Mandir, simbolo della decolonizzazione…’: Rajnath Singh al lancio del libro ‘Tryst with Ayodhya’”, video YouTube, 4:28, Economic Times, 13 gennaio 2024, economictimes.indiatimes.com.
- ↩ “India o Bharat: cosa c’è dietro la disputa sul nome del Paese?”, Al Jazeera, 6 settembre 2023.
- ↩ Sanya Dhingra, “Come i nazionalisti indù hanno ridefinito la decolonizzazione in India”, New Lines, 14 agosto 2023.
- ↩ “L’India ha ottenuto la libertà dopo 1.000 anni di dominio straniero, Narendra Modi dice al Congresso degli Stati Uniti”, Scroll, 23 giugno 2023, scroll.in.
- ↩ Shalini Sharma, “India: come alcuni nazionalisti indù stanno riscrivendo la storia delle caste in nome della decolonizzazione”, The Conversation, 9 maggio 2019.
- ↩ Jan C. Jansen e Jürgen Osterhammel, Decolonizzazione: una breve storia (Princeton: Princeton University Press, 2017), 4.
- ↩ Raymond F. Betts, “Decolonizzazione: una breve storia della parola”, in Beyond Empire and Nation, a cura di Els Bogaerts e Remco Raben (Leiden: Brill, 2012), 27.
- ↩ Frantz Fanon, I dannati della terra (New York: Grove Press, 2007), 2–3.
- ↩ Musarrat Maisha Reza, “Decolonizzare la medicina, prima parte: fare i primi passi”, Times Higher Education, 13 aprile 2022; Steven Mintz, “Decolonizzare l’Accademia”, Inside Higher Ed, 21 giugno 2021; Annie Liu, “Dì sì all’amore decoloniale: 5 modi per resistere all’oppressione nelle tue relazioni”, Everyday Feminism, 9 dicembre 2014.
- ↩ Aníbal Quijano, “Colonialità e modernità/razionalità”, Cultural Studies 21, n. 2-3 (marzo 2007): 170-71
- ↩ Walter D. Mignolo, Il lato oscuro della modernità occidentale: futuri globali, opzioni decoloniali (Durham: Duke University Press, 2011), 8.
- ↩ Walter Mignolo e Catherine E. Walsh, Sulla decolonialità: concetti, analisi, prassi (Durham: Duke University Press, 2018), 4.
- ↩ Mignolo e Walsh, Sulla decolonialità, 120.
- ↩ Rama Lakshmi, “Gli indiani hanno inventato gli aerei 7.000 anni fa e altre affermazioni sorprendenti al Congresso della Scienza”, Washington Post, 1 dicembre 2021; “L’antica India aveva aeroplani, armi nucleari, dice il capo del principale organo di storia dell’India”, India Today, 21 novembre 2014; Alexis C. Madrigal, “Un politico indiano ha affermato che gli antichi indù hanno inventato Internet”, The Atlantic, 24 aprile 2018.
- ↩ J. Sai Deepak, India, Ovvero Bharat: colonialità, civiltà, costituzione (Delhi: Bloomsbury India, 2021).
- ↩ Anandaroop Sen, “L’India di J Sai Deepak che è Bharat: colonialità, civiltà, costituzione”, Social Dynamics 49, n. 2 (maggio 2023): 379.
- ↩ Come ha scritto lo studioso Dibyesh Anand su X nell’agosto 2021: “Decano della ‘decolonialità’, Mignolo approva un libro che è apertamente suprematista indù. Gli altri sostenitori, compresi gli islamofobi ben consolidati, come Elst”.
- ↩ “Scheda informativa: Hindu Swayamsewak Sangh (HSS)”, Bridge Initiative, 4 gennaio 2024, bridge.georgetown.edu. Hindu YUVA ha postato su X all’epoca: “L’evento ‘Bharatam’ alla UC Berkeley è iniziato con una preghiera dei nativi americani guidata da Kanyon Sayers della Indian Canyon Nation”.
- ↩ Sen, “L’India di J Sai Deepak che è Bharat”, 382.
- ↩ Priyamvada Gopal intervistata da Shozab Raza e Hadia Akhtar Khan, “L’impero e i suoi nemici: una conversazione con Priyamvada Gopal”, Jamhoor, 8 agosto 2022.
- ↩ Idi Amin citato in Jan Jelmert Jørgensen, Uganda: A Modern History (Londra: Helm, 1981).
- ↩ Mahmood Mamdani, “L’espulsione asiatica ugandese: vent’anni dopo”, Journal of Refugee Studies 6, n. 3 (1993): 269-70.
- ↩ Fanon, I dannati della terra, 105.
- ↩ Fanon, I dannati della terra, 163, 168.
- ↩ Aimé Césaire, Discorso sul colonialismo, trad. Joan Pinkham (New York: Monthly Review Press, 2000), 44-45.
- ↩ Robin D. G. Kelley, “Una poetica dell’anticolonialismo”, in Césaire, Discorso sul colonialismo, 27.
- ↩ Amílcar Cabral, “Liberazione nazionale e cultura”, Transizione, n. 45 (1974): 16.
- ↩ Cabral, “Liberazione nazionale e cultura”.
- ↩ Fanon, I dannati della terra, 2.