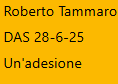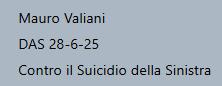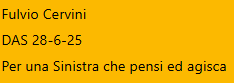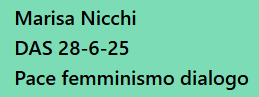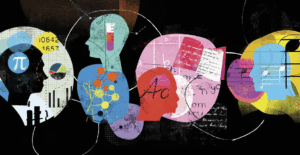Guerre culturali e neoliberismo

Il Report contiene
Scheda del libro
Indice
Introduzione
Rec. Roberto Barzanti su Il Manifesto
Rec. Antonio Del Castello su Nazione Indiana
Rec. Raffaele Alberto Ventura su Domani
Scheda
Cangiano, Mimmo
Guerre culturali e neoliberismo / Mimmo Cangiano. – Milano : Nottetempo, 2024. – 189 p. ; 20 cm. – (Nottetempo. Figure).) – [ISBN] 9791254800782.
Indice
Introduzione
1. Brevemente il dibattito, ovvero America is everyone’s future
2. Particolarismo militante
3. Il background postmodernista, ovvero la “naturalizzazione del molteplice”
4. Unmasking the power
5. “La breve cronaca del tempo”: intellettuali e culturalismo
6. “Se ci regola il mercato”: capitalismo e ragione strumentale
7. The revolution starts in your mind : etica e privato
8. Diversamente (ma oggettivamente) classe
9. Intersezionalità e totalità
Ringraziamenti
Note
Introduzione
Questo non è un libro sulla cancel culture (anche se ogni tanto si parla di cancel culture ), e neanche un libro sul politicamente corretto (anche se qualche volta si parla di politicamente corretto); è invece un volume che tenta da un lato di ricostruire il dibattito – e la sua genealogia – su tutta una serie di temi che sono diventati il centro delle attuali culture wars (questioni identitarie, di classe, anti – razzismo, anti – sessismo, prospettive liberal , postmodernismo, ruolo della Theory ), dall’altro di proporre alcune soluzioni interpretative in un quadro di analisi che, fortemente propenso a prestare orecchio alle nuove questioni emerse, resta ancorato al materialismo storico. Questo libro non è scritto per criticare la cosiddetta woke (e sulla problematicità di questo termine ci soffermeremo a breve), ma per provare a superare quel non piccolo quid di liberalismo e di culturalismo che le culture wars mi paiono portare con sé; è dunque un libro che mira a sottrarre la woke a sospette derive liberal , materializzando i suoi temi attraverso la loro dialettica con i processi socio – materiali (produzione, mercato, lavoro, consumo) in atto.
Per far ciò era però anzitutto necessario chiarire le ragioni di quell’aria di famiglia avvertita nella geremiade di tematiche, politiche e anche accademiche, ormai da tempo al centro della sequela di polemiche e discussioni che, dagli Stati Uniti, si sono riversate nei mercati culturali di gran parte del globo. E in tal senso è stato fondamentale sia ricostruire le diverse prospettive del dibattito corrente, sia mostrare il modo in cui tanto la produzione culturale quanto i processi socio – materiali hanno preparato il dibattito in corso.
Il proposito è dunque duplice. Da un lato si tratta di chiarire il modo in cui le culture wars si sono “stabilizzate” in una serie ormai riconoscibile di tematiche, quelle espresse a livello giornalistico – divulgativo mediante sintagmi quali politically correct , cancel culture , ideologia del gender ecc., e, a livello accademico, tramite lo sviluppo di prospettive che, dalla Theory agli Studies , hanno sempre più posto l’accento sulle dinamiche di potere e privilegio connesse ai rapporti e ai costrutti socio – culturali. Dall’altro lato si tratta, analizzando la woke da una prospettiva materialista (una prospettiva che, si vedrà, sottopone ugualmente a critica gli approcci rosso – bruni al tema 1 ), di sottolineare i rischi della sua trasformazione in una postura riformista saldamente ancorata ai modi di funzionamento, materiale e ideologico, della società corrente e del suo mercato.
Benché abbia cercato il più possibile di evitare il “secondo me” tipico della tradizione saggistica, riportando invece la materia trattata a un discorso fattuale – mirato cioè a evidenziare effettivi dati di formazione culturale e materiale delle guerre culturali – , questo alla fine è anche un libro in qualche modo personale, e come tale fortemente centrato, anche nei molti esempi riportati, sui miei dieci anni di vita statunitense, quando e dove ebbi l’occasione, se così si può dire, di vedere formarsi un’egemonia culturale, in tempi in cui in Italia, almeno al livello del dibattito giornalistico e politico, tutto ciò era di là da venire.
Il primo capitolo è dunque dedicato a squadernare le diverse posizioni che numerosi intellettuali, da sinistra a destra dello spettro politico, hanno negli ultimi anni manifestato nei confronti delle prospettive woke , portando a critica tanto le visioni destrorse quanto quella nutrita serie di testi che ha attaccato il nuovo impianto culturale senza però sottolinearne il nesso dialettico con le ristrutturazioni materiali che stavamo e stiamo attraversando. Il secondo capitolo entra nel vivo della questione e analizza sia i rapporti fra le culture wars e alcune prospettive della politica corrente, sia il macro – tema delle identity politics .
Il terzo e il quarto capitolo si confrontano con le prospettive accademiche affini alla woke . In particolare, nel terzo capitolo si analizza il complesso rapporto di filiazione fra French Theory e culture wars , nel quadro del passaggio a sinistra delle tematiche postmoderniste, mentre il quarto è incentrato sulle attuali prospettive politiche del macro – campo degli Studies , divenuti ormai una sorta di braccio esecutivo della stessa Theory . Se poi il quinto capitolo è dedicato alla questione del culturalismo (vale a dire, al rischio di una lettura delle modalità d’azione del capitale su base puramente culturale), il sesto capitolo – il più corposo – tratta di tutte quelle strane affinità che si riscontrano fra le rivendicazioni di questa nuova cultura di sinistra e i modi di operare di parte del mercato capitalista.
Il settimo capitolo affronta la questione dell’etica woke in relazione al corrente sistema di relazioni sociali, al crescere dell’individualismo e dell’auto – mercificazione, mentre gli ultimi due capitoli si concentrano infine sulle questioni, io credo fondanti, della classe e dell’intersezionalità.
La mia speranza è che, alla fine del libro, il lettore, oltre ad avere una visione più nitida su tutta una serie di problemi, veda la possibilità di sussumere in un progetto unitario le contraddizioni che ci attanagliano, anche comprendendo che queste sono contraddizioni materiali, originatesi nella dialettica fra il corrente modo produttivo e il sistema di relazioni sociali – e le soggettività – che questo crea. Pure per questa ragione ho evitato di riportare tutti quegli esempi di manifestazioni pubbliche della woke che, da qualche anno, costituiscono ormai un vero e proprio genere pubblicistico mirato a far affiorare l’indignazione dei lettori secondo un ben preciso indirizzo ideologico, teso a sottolineare un nesso fra culture wars e “fanatismo” progressista. Lo scopo di questo libro non è infatti, come già accennato, quello di formulare un ennesimo giudizio etico – culturale sulla woke , ma cercare di comprendere le ragioni della sua formazione, oltreché le possibilità politiche, e i rischi, che tale posizionamento presenta in rapporto al sistema di relazioni sociali in cui siamo, woke inclusa, immersi.
Rec di Roberto Barzanti
Il Manifesto 23 giugno 2024
DA NOTTETEMPO. «Guerre culturali e neoliberismo», un saggio di Mimmo Cangiano
Cultura e lessico Woke hanno usurpato la dialettica ‘classe lavoratrice’-capitalisti
Roberto Barzanti
Leggerlo oggi, quando nei campus divampano proteste dalla lunga incubazione e si issano cartelli pro-Palestina o rilanciando parole d’ordine che la cultura woke ha iniziato a scandire decenni fa, insinua qualche dubbio di anacronismo. La situazione in molte Università negli States è cambiata, registra radicalizzazioni che covavano sotto la cenere, e ha trovato slogan unificanti contro un nuovo Vietnam. Invece questo densissimo Guerre culturali e neoliberismo (nottetempo, pp. 192, €17,00), a metà tra resoconto diaristico e riflessione filosofica, che Mimmo Cangiano (casertano, 43 anni, docente a Ca’ Foscari di critica letteraria e letterature comparate) tratta temi più attuali che mai con rara incisività.
Descrive debolezze e potenzialità delle culture wars sulla base dell’esperienza diretta di quasi dieci anni di insegnamento e confronti tra studenti e professori degli atenei d’oltreoceano. E nell’introduzione mette subito in guardia. Oggetti delle sue note non saranno la deprecata e talvolta grottesca (ma diffusissima) cancel culture, né soltanto le battaglie ingaggiate su questioni identitarie di gruppi etnici, classiste, anti-razziste, antisessiste, o condotte all’insegna di un proteiforme postmodernismo oppure all’ombra della French Theory dei post-strutturalisti francesi.
E neppure insisterà su cultural studies, gender studies, queer studies alla ribalta dagli anni settanta. Con l’acume estesamente dimostrato nel ponderoso Cultura di destra e società di massa. Europa 1870-1939 (2022), Cangiano qui si concentra su un inquietante problema di strategia, che investe le forze che più o meno si collocano a sinistra, ma non è estraneo a differenti, se non opposti, ambienti.
Non esiste il rischio che la dimensione woke ignori i fondamenti materiali di un capitalismo malandato ma totalizzante, trasformistico e mimetico, in grado di annettersi, magari ipocritamente, rivendicazioni antagonistiche? Il «culturalismo» non si presta a seminare illusioni e a offuscare o rimuovere, nel pensiero e nell’azione politica, i rapporti di produzione che stanno alla base di disuguaglianze crescenti e cinici sfruttamenti?
Non sussiste il rischio che la sensibilità etica – da noi si direbbe il buonismo – impedisca di mettere all’ordine del giorno un marxismo rinnovato all’altezza dei tempi? Anzi, per dirla alla buona con un termine che viene pronunciato malvolentieri, rimuova il materialismo di processi e condizioni che si attribuiscono a un passato industrialista ben lontano dall’essere il motore di una storia «finita»?
Do la parola all’autore trascrivendo uno dei passi più espliciti del suo martellante discorso: «Cultura e ideologia usurpano progressivamente le posizioni in precedenza assegnate ai due motori di prassi contrapposti: classe lavoratrice e capitalisti». E aggiunge: «La battaglia simbolica, di conseguenza, si pone sempre più al centro sia del dibattito intellettuale sia del contrasto politico». L’autore sa bene che una ripresa dell’interpretazione della realtà effettuale avvalendosi di categorie fordiste sarebbe fuori dalla non circoscrivibile gabbia mediatica in cui ci aggiriamo.
Le forme del capitalismo si sono dislocate e nascoste al punto di essersi come naturalizzate agli occhi di una manipolata opinione pubblica. E quanto alla classe – meglio alle classi – la dispersione e la liquefazione dei rapporti l’hanno frammentate in segmenti che non formano un popolo. Infondate le lamentazioni di chi grida allo scandalo perché non esiste da noi un partito democratico della sinistra in quanto privo di «popolo»: nobile categoria ottocentesca. A meno che non si voglia sostituire con una moltitudine che non si presenterebbe certo come corpo dotato di compattezza e unità.
Abbiamo naturalizzato il capitalismo-potere accedendo a un «essenzialismo di ritorno» secondo l’espressione della creativa scrittura dell’autore: sicché si è spinti a pensare che ne sia impossibile il rovesciamento: al più si tenteranno correzioni o ci si contenterà di una sorta di galateo semantico. Il lessico woke designa movimenti per i diritti civili e per una sequela di diritti di nuovissimo conio tutt’altro che inutili. Ma il loro sbocco non andrà oltre i limiti entro cui si agita. «Questo, ovviamente non significa – osserva Cangiano –, come un marxismo volgare ha creduto, che la lotta culturale sia inutile, ma significa che, se questa non viene intesa in relazione dialettica con il piano dalla produzione, del mercato, del consumo, la sua risultante sarà liberale».
Conclusione meno apocalittica e cupa di quanto pareva profetizzabile dopo le curiose esplorazioni accademiche americane. «La mancata riflessione – egli ha ribadito in una recente intervista – sul rapporto dialettico fra piano della produzione delle idee e piano della loro socializzazione (fuori dalle “bolle” dei social), inevitabilmente incancrenisce la lotta proprio lasciandola sul mero piano “culturalista”, e crea quei fenomeni di irrigidimento moralistico che ormai conosciamo bene anche in Italia. La politica lascia il posto all’etica, e questa spesso si riduce a un atteggiamento di accusa verso chi non è (o non è abbastanza) woke».
Rec. di Antonio Del Castello
Su “Guerre culturali e neoliberismo” di Mimmo Cangiano
Se avessero guardato alla classe operaia come a un’identità oppressa e marginale, cioè con il dispositivo vittimario e con le categorie etico-culturali vigenti oggi tra i liberal degli Stati Uniti e di parte dell’Europa, Marx ed Engels avrebbero dovuto limitarsi a un silenzio autocolpevolizzante, impegnandosi semmai a decostruire il proprio privilegio identitario di borghesi (soprattutto il secondo, figlio di un ricco industriale renano) e il proprio classismo magari inconscio, per evitare di causare discomfort negli individui identificantisi nel gruppo sociale oppresso. È questo uno dei paradossi a cui può essere portato a pensare chi legga Guerre culturali e neoliberismo diFrench Theory
Cangiano ci aveva abituato a saggi voluminosi (rispettivamente di 628 e 525 pagine) e impegnativi, oggi ci offre un libro relativamente breve (189 pagine) e maneggevole, nonostante la difficoltà teorica dei problemi che affronta. Il primo dei tre, ripercorrendo la storia sociale degli intellettuali italiani di primo Novecento (1903-1922) e del loro programma di egemonia piccolo-borghese da esercitare sugli intellettuali di strato inferiore (come giornalisti e insegnanti), aveva individuato nel modernismo la «logica culturale» della fase imperialista del capitalismo, sorretta da filosofie (contingentismo, pragmatismo, ecc.) adatte a una borghesia intellettuale (non tecnica) in crisi nella fase di modernizzazione capitalistica dell’Italia. Il secondo aveva proposto una mappa dettagliata dell’intellighenzia europea di destra attiva tra il 1870 e il 1939 nel segno di una strategia che includeva «un approccio culturale alla politica e, spesso, un approccio politico alla cultura» ovvero una «possibile sovrapposizione tra artistico e politico».
Terzo tassello, Guerre culturali e neoliberismo è il saggio meno accademico di Cangiano, non solo per i libri da cui in parte prende le mosse o che possono più immediatamente essere individuati come suoi compagni di strada (penso, tra gli altri, per restare all’ultimo decennio in Italia, ai saggi di Daniele Giglioli ed Elisa Cuter), ma per il taglio argomentativo-narrativo e anche autobiografico, che muove dall’esperienza quasi decennale dell’autore negli Stati Uniti, il paese che è «everyone’s future», come recita il titolo del capitolo I.
Il libro propone una critica del “culturalismo” (disseminata ovunque ma concentrata nel cap. V) e delle possibili derive liberali tanto della cultura woke quanto della sua controparte universitaria, cioè la Theory e gli Studies, quell’indirizzo di studi incentrato sulle dinamiche di potere e privilegio legate a tradizioni e canoni letterari. Per cultura woke si intende invece quel posizionamento progressista che include le identity politics, ossia l’individuazione, in prospettiva principalmente etica e linguistico-culturale, di identità plurime marginali e oppresse (genere, razza, e anche classe, come vedremo meglio in seguito); il safetyism, cioè l’ideologia della sicurezza emotiva (comfort) diventata centrale nell’etica di sinistra; l’inclusività, l’attenzione ai privilegi, ecc. Ciò che insomma la destra ha cominciato a chiamare cultural marxism, la «riformulazione, in ambito etico-culturale, di un marxismo sconfitto sul piano economico-politico» (p. 17). Di tutto questo si ricostruisce la storia e soprattutto si tenta una riconnessione con i processi materiali con i quali è in relazione dialettica: produzione del valore, mercato e sfruttamento del lavoro, ecc.
Il «culturalismo» di cui si parla qui è, infatti, l’atteggiamento che attribuisce assoluta preminenza agli aspetti simbolici della politica, raggiungendo in questo anche un notevole livello di radicalismo, senza però che ciò implichi (più) una richiesta di trasformazione materiale del sistema economico; un atteggiamento, quindi, che tende a politicizzare ogni aspetto della vita e della cultura mentre accetta, di fatto, la totale depoliticizzazione (e quindi naturalizzazione) dell’economia; una strategia della «guerra culturale» che, avendo ormai perso di vista la dialettica tra cultura, struttura economica e orizzonte della prassi, individua in sé stessa il proprio fine. Anche l’individuazione delle identità, siano esse privilegiate o subalterne, avviene per lo più in ottica puramente etico-culturale, in totale disconnessione da una prospettiva materiale focalizzata, invece, sulla realtà dello sfruttamento del lavoro e sull’estrazione di valore economico da esso (capp. i-iv).
La seconda parte del libro entra nel merito del complesso modo in cui il capitale, con i suoi molteplici standard di azione, può rendere il culturalismo (cap. VI) e l’etica woke (cap. VIII) perfettamente compatibili con le proprie esigenze. È, questo, un tema assolutamente centrale, perché è su questa base che il libro riesce nel suo compito forse più difficile: quello di sottoporre a critica il culturalismo e l’etica woke non solo evitando, ma anzi al tempo stesso decostruendo, e con inedita efficacia, le distorsioni “rosso-brune” che fino a questo momento ne avevano costituito la vulgata critica. Ci si riferisce qui a quelle tendenze (i cui capofila in Italia sono il filosofo Diego Fusaro e, volendo, il politico Marco Rizzo) che, sovrapponendosi al sovranismo della destra estrema, assumono che lo Stato possa agire come baluardo contro il mercato, e oppongono strumentalmente diritti civili e diritti sociali accusando la cosiddetta “sinistra fucsia e globalista” di fare il gioco dei liberali e del capitale globale, interessato, al fine di promuovere nuovi consumi, a favorire individualismo, sradicamento, fluidità, ecc.
Ricostruendo questo fenomeno è possibile individuare un vero e proprio «cultural turn», una ‘svolta culturalista’ che nel iv capitolo è perfettamente definita non solo, o non tanto, come lo spostamento del conflitto sul piano psicologico, linguistico e ideologico, quanto piuttosto come «la disconnessione di quest’ultimo dal piano economico-strutturale», come «un progressivo decadimento delle richieste di uguaglianza economica a favore di quelle connesse al riconoscimento simbolico» (p. 72). Una svolta vista sull’orizzonte della raggiunta egemonia neoliberale e della conseguente impotenza politica della sinistra (negli anni dieci al centro dei saggi di Giglioli). [1] Un orizzonte segnato da un realismo politico (cioè un assetto psichico, cognitivo ed estetico) che ha radicalmente ridefinito il campo di ciò che è possibile in fatto di politica ed economia, e che per questo ci fa apparire il mercato neoliberale, con la sua violenza endemica, come mediatore universale di ogni relazione umana e habitat naturale dell’umanità del XXI secolo, e che in conseguenza fa apparire, non solo come impossibile, ma addirittura impensabile, qualsiasi alternativa (There is no alternative). Insomma, ciò che, finito il sogno (o l’incubo) della rivoluzione, cioè della possibilità di trasformazione e superamento delle contraddizioni del nostro sistema economico, siamo ormai abituati a chiamare, con Mark Fisher (1968-2017), «realismo capitalista».[2] Il «cultural turn» segnerebbe dunque il passaggio da un’idea di battaglia culturale per la conquista di un’egemonia utile a rovesciare i rapporti di produzione a una “guerra culturale” vista, ormai, in dimensione definitivamente strategica: il fine – perché unica possibilità percepita – dell’azione politica individuale.
Cangiano non mette mai in discussione il fatto che sia giusto politicizzare (o ripoliticizzare) sfere private (come l’identità di genere o l’orientamento sessuale) a lungo escluse dalla lotta politica, ma segnala i limiti di un’operazione di questo tipo quando sia attuata sullo sfondo di una de-politicizzazione dell’economia e dei rapporti di produzione, che sempre più spesso, ormai, nell’orizzonte del realismo capitalista, vengono “essenzializzati”, cioè appunto percepiti come naturali o comunque immutabili. Come già detto, d’altronde, è proprio di fronte all’impotenza percepita rispetto all’azione trasformativa che il radicalismo si sarebbe trasferito, riducendosi, sul piano meramente culturale e simbolico. «Il primo rischio è dunque che, mentre politicizziamo tutto, finiamo per de-politicizzare proprio l’economia, per cui possiamo vedere come correttivi concetti quali l’“inclusione” – cioè, la richiesta di partecipazione paritaria a un sistema che resta, tuttavia, basato sullo sfruttamento» (p. 34).
Si tratta, insomma, di comprendere il doppio tavolo su cui il capitalismo gioca. Purché sia salva la possibilità dello sfruttamento, loro unico fine, i capitalisti (e i governi che li sostengono) possono tanto strumentalizzare (nonché aizzare) il sessismo e il razzismo presenti nella società per sfruttare meglio la manodopera, il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura di donne e migranti, quanto mettere a valore i discorsi di emancipazione che montano dal basso in campagne di marketing all’insegna del black, del pink o del rainbow washing. «Il capitale – in una formulazione di Elisa Cuter – mobilita l’erosione del binarismo di genere come la sua ratificazione, a seconda di quanto gli fa comodo». [3] La società capitalistica è, del resto, «culturalmente egualitaria», come ha ricordato Giglioli, sulla scorta di Tocqueville.[4] Sbagliano dunque, per Cangiano, tanto i woke a pensare che il capitale agisca solo nel senso dell’universalismo oggettivante e normativo (maschile, eurocentrico, imperialista: Dio, patria e famiglia), quanto i rosso-bruni a pensare che il capitale, per incentivare nuovi consumi, punti al contrario soltanto al pluralismo relativistico e alla frantumazione delle identità.
«Ogni relazione di oppressione – è un’altra fondamentale tesi del libro di Cangiano – è connettibile al quadro dello sfruttamento a fini di profitto» (p. 40). A chi legge potrebbe venire fatto di chiedersi se questo è vero. Anche l’oppressione patriarcale? Anche l’oppressione di genere, anche il razzismo sono davvero tutti risolvibili nell’ottenimento di plus-lavoro al fine di creare plus-valore? Il privilegio maschile messo in discussione dal femminismo non è forse più antico del capitalismo? Il valore simbolico collegato all’onore maschile non agisce con più forza proprio in contesti segnati dalla penuria economica? Sul piano storico ciò è innegabile e Cangiano infatti non lo nega. Qui, però, la sua lettura non è più storiografica, ma strategica, nel senso della prassi: «Se precisi e vigenti rapporti di potere, come il patriarcato o la whiteness, pur preesistenti al capitalismo, non vengono intesi sulla base dell’uso che ne fanno (o non ne fanno!) i capitalisti nella loro lotta per il profitto, sarà quasi inevitabile separare il campo etico-culturale del privilegio da quello materiale dello sfruttamento» (p. 44).
Se si separano i due campi, è inevitabile la frammentazione del fronte dei subalterni, perché le identità sfruttate sul piano economico ma percepibili come privilegiate sulla base della razza e del genere (e cioè il maschio bianco abile e cisgender appartenente alla classe lavoratrice), non potranno essere viste come compagne nella lotta, e le energie impiegabili in una auspicabile prassi trasformativa del sistema economico si esauriranno, nel migliore dei casi, nella riflessione sul proprio privilegio identitario (check your privilege). Così facendo, il compito non sarà più confrontarsi «con il capitale o con lo Stato che produce sfruttamento e oppressione, ma con il discomfort che il [proprio] privilegio può produrre nei [propri] stessi alleati» (p. 37): ideologia del safetyism che viene decostruita (vedi pp. 136 e sgg.) tramite il chiarimento della sua relazione con un contesto sociale segnato da grande precarietà economica (rispetto alla quale la sicurezza emotiva resterebbe l’ultimo privato rifugio dopo la scomparsa del welfare, cioè della sicurezza sociale) e competizione interpersonale. La condotta individuale votata al rispetto del benessere emotivo altrui e l’etica (ironicamente definita da Lukács come «la prassi dell’individuo isolato», come ricorda Cangiano) resterebbero dunque le uniche possibilità di azione dopo la fine dei progetti di radicale trasformazione sociale seguiti alla sconfitta storica del movimento operaio di fine ’900.
Che fare, dunque? E ciò che chi legge non può che attendersi dai capitoli finali (VIII-IX) del libro. Bene, questi suggeriscono innanzitutto di recuperare la categoria relazionale di classe contro quella individualizzante e vittimizzante di identità: «La classe è un posizionamento sociale che, con tutte le possibili differenze interne (di genere, razza ecc.), accomuna un gruppo di persone nella forma in cui si relazionano al modo di produzione (vendita della propria forza lavoro ecc.); e come tale, la classe in cui una persona ricade non è necessariamente fissata per la vita: deriva da ciò che fai, non da chi sei» (p. 149); in altre parole, di rovesciare il dispositivo della vittima in un nuovo paradigma della forza sociale: di finirla con la divisione del fronte dei subalterni su base identitaria e tentare una sua ricomposizione, come già ha invitato a fare Elisa Cuter, sulla base dei comuni obiettivi (e desideri) politici.[5]
Giglioli aveva visto nel «dispositivo vittimario» il più forte generatore di identità funzionante oggi: l’identità (essente, passiva) avrebbe preso il posto del soggetto (agente, attiva).[6] Come giustamente ricorda Cangiano, e ricollegandoci al paradosso da cui siamo partiti, nulla di meno marxista sarebbe stato, nelle prime epoche del capitalismo, interessarsi alla classe operaia in quanto oppressa. La classe operaia è centrale, nella lettura marxiana, in quanto è su di essa e sullo sfruttamento del suo lavoro che si basa l’intero sistema economico.
Un nodo attende ulteriore riflessione. Meglio: una domanda potrà essere formulata con maggiore radicalità. Se la risposta a questa domanda potrà venire soltanto dal terreno concreto delle pratiche di lotta, a questo libro dovrà molto la correttezza della sua formulazione. In un sistema, come il capitalismo, fondato sullo sfruttamento del lavoro, non può che essere ancora la working class «la categoria sociale centrale (insieme al capitale)» (p. 150). Se non questa, nessuna. E se così non fosse, del resto, non ci sarebbe alcuna possibilità, nemmeno teorica, di presa di controllo del modo di produzione capitalistico e della sua trasformazione.
Ma se il baricentro di questa classe si è modificato a misura dei mutamenti nella produzione, con la fine del fordismo, la delocalizzazione industriale, la terziarizzazione e la nuova centralità che il lavoro affettivo, relazionale, creativo e cognitivo ha nella produzione di valore nella nostra società (Cangiano ne è perfettamente consapevole); se «dobbiamo ora operare con tutta una serie di soggetti e gruppi sociali la cui relazione col modo produttivo, il cui essere classe, è meno evidente» (p. 160), allora bisogna forse tentare di trasformare le culture wars, da conflitti che dividono il fronte degli oppressi, in una lotta per l’egemonia all’interno del campo degli sfruttati. E si potrà farlo, anche grazie a questo libro, tramite la comprensione della dialettica tra oppressione e sfruttamento, e tramite la riconnessione della lotta culturale al piano materiale della produzione e del mercato capitalistico.
Il concetto di intersezionalità (esaminato nell’ultimo capitolo), emerso storicamente in risposta al problema della potenziale concorrenzialità fra le varie identità subalterne, non risolve il problema se riduce la classe, come fa la cultura woke, a un’identità oppressa tra le altre (insieme a genere, razza, ecc.). Riconsiderare l’intersezionalità materialisticamente, «cioè a partire dalla relazione che intratteniamo con produzione e mercato, non dalla condizione di vittima» (p. 168), implica allora uno sforzo ulteriore di individuazione dei soggetti che possano guidare la classe lavoratrice dopo la crisi di fine ’900. Se non può più farlo l’operaio industriale, marginalizzato (in questo caso sì) dall’automazione e dalla delocalizzazione industriale), potrebbero appunto essere le donne – in quanto, per ragioni storiche legate alla nostra società divisa e messa interamente al lavoro dal capitalismo, si trovano al centro del lavoro di relazione, riproduzione e cura, a sua volta centrale nel capitalismo contemporaneo – a guidare la classe lavoratrice globale del XXI secolo.
__
Note:
[1] Cfr., di Daniele Giglioli, Critica della vittima, Milano, Nottetempo, 2014, e Stato di minorità, Roma-Bari, Laterza, 2015.
[2] Cfr., di Mark Fisher, Realismo capitalista (2009), trad. it., Roma, Nero, 2018, e Il nostro desiderio è senza nome. Scritti politici. K-Punk/1, trad. it., Roma, Minimum Fax, 2020, in part. le pp. 153, 177, 291 e sgg.
[3] Elisa Cuter, Ripartire dal desiderio, Roma, Minimum Fax, 2020, p. 93.
[4] Daniele Giglioli, Stato di minorità, cit., p. 58.
[5] Elisa Cuter, Ripartire dal desiderio, cit., p. 198.
[6] Daniele Giglioli, Stato di minorità, cit., pp. 48 e passim.
lìarticolo è pubblicato su: Su “Guerre culturali e neoliberismo” di Mimmo Cangiano | NAZIONE INDIANA
Recensione di Raffaele Alberto Ventura
Pubblicato su Domani del 2 maggio 2024
Il fantasma del woke si aggira per l’Europa. Dalle sue derive ci salverà il marxismo?
La sinistra è ormai scissa tra boomer che immaginano un totalitarismo woke e attivisti che non credono più nella lotta di classe, ma nella politica dell’identità. La prospettiva marxista offre come sintesi di questa contraddizione una conciliazione tra diritti civili e lotta di classe, contro un capitalismo che sembra parlare la lingua del wokismo. È il tema del nuovo libro di Mimmo Cangiano, Guerre culturali e neoliberismo (Nottetempo)
Prima di andare a dormire io non conto più le pecorelle: conto le sinistre. Nel dormiveglia, da principio, ne vedo una sola, quella caricaturale che vuole che non si dica nulla per non offendere nessuno. Esiste, certo, ma non è poi tanto maggioritaria: la si trova soprattutto sui social network. Successivamente lo stato ipnagogico imprime sulle mie retine una seconda sinistra: è il vecchio ceto medio riflessivo, secondo cui il politicamente corretto ha passato il segno. Qualcuno lo chiama “boomer”: legge Repubblica, rimpiange gli anni della liberazione sessuale e difende con le unghie e coi denti la libertà d’espressione.
Poi l’altra sera ho letto il nuovo libro di Mimmo Cangiano, Guerre culturali e neoliberismo (Nottetempo), e in piena fase rem è apparsa un’altra sinistra, che propone il superamento dialettico della contraddizione: è la sinistra marxista. Cangiano ricorda che esistono questioni più serie della tinta dei vostri capelli blu: avete mai sentito parlare di rapporti di produzione? Oh no, è arrivato il compagno Folagra. A quel punto sono iniziati gli incubi e le sinistre sono diventate dieci, cento, mille, praticamente il multiverso della follia. Forse dovrei tornare a contare le pecore.
Si potrebbe credere che queste divisioni siano il prodotto di un dibattito recente, e invece sono lo strascico di dibattiti di oltre mezzo secolo fa. Negli anni 1950 i liberal antisovietici, lettori di Karl Popper e Hannah Arendt, si erano allenati a cogliere ovunque segnali di un incipiente totalitarismo: nella rivoluzione comunista e poi in qualsiasi timido tentativo di riforma sociale.
Vent’anni dopo una generazione d’intellettuali ferocemente antimarxisti – il più celebre è Michel Foucault, seguace di Nietzsche e Heidegger – liquidava la lotta di classe e spostava la politica sul piano dei micropoteri. Sono gli eredi di queste due generazioni di intellettuali della Guerra fredda che, oltre ad apparirmi in processione quando mi addormento, monopolizzano il dibattito contemporaneo.
Da una parte ci sono quelli che denunciano un nuovo totalitarismo, il totalitarismo woke. In nome dei valori liberali della modernità politica – l’universalismo in primis – sembrano pronti a convertirsi al suprematismo, un suprematismo ipermoderno. Le loro sono idee di sinistra, quelle del liberalismo ottocentesco, che hanno fatto il giro per diventare di destra. Dall’altra parte ci sono i promotori postmoderni della cosiddetta politica dell’identità. Secondo loro l’appartenenza a un gruppo subalterno – magari etnico-razziale – è il primo criterio di soggettivazione politica: queste invece sono idee di destra, quelle del vecchio pensiero controrivoluzionario, che hanno fatto il giro per diventare di sinistra. Poi capite perché faccio fatica ad addormentarmi.
INTERNAZIONALISMO CONTRO INTERSEZIONALISMO
Per fortuna Cangiano è qui per salvarci. Dopo aver demolito le panzane di chi denuncia la cultura woke come una forma di «marxismo culturale», mentre invece ne è l’esatto contrario, offre una lettura critica delle sue derive. Non è l’unico, come si capisce dalle numerose citazioni contenute nel libro. Basta poi farsi un giro in libreria per trovare delle letture affini, come l’ultimo saggio dell’antropologo francese Jean-Loup Amselle, A ciascuno il suo Marx (Meltemi).
In quella che è innanzitutto un’autobiografia intellettuale, Amselle critica la tendenza di alcuni segmenti della sinistra a enfatizzare le questioni identitarie, perdendo di vista quelle economiche. In particolare mette in guardia contro l’essenzializzazione delle identità. L’antropologo esplora la complessità delle identità individuali e collettive, argomentando che ogni identità è intrecciata in una rete di determinazioni sociali che trascendono le semplici etichette.
Cangiano va nella stessa direzione ma si spinge oltre. Cos’è la cultura woke, con la sua attenzione per la diversità e l’inclusione, se non un discorso che il capitalismo fa su sé stesso nel tentativo di adattarsi alla società multiculturale? In effetti la politica dell’identità, neutralizzando la lotta di classe e offrendo agli sfruttati delle compensazioni simboliche, mira sostanzialmente al contenimento delle tensioni sociali. L’attivismo serve così da foglia di fico al management della diversità. In questo modo, «la sinistra rischia di trasformarsi nel dipartimento risorse umane del capitale».
Secondo Cangiano c’è una «omologia morfologica» tra le parole dell’impresa neoliberale e quella dei giovani militanti. Insomma se trent’anni fa il postmodernismo era stato denunciato – da Frederick Jameson – come la logica culturale del tardo capitalismo, oggi quella stessa logica avrebbe assunto i tratti dell’inclusività, un’operazione di lifting che serve a dare un volto umano al solito vecchio sistema di sfruttamento.
Questo è dunque un ostacolo a ogni politica rivoluzionaria. Da buon marxista, Cangiano afferma che il particolarismo delle rivendicazioni di razza e genere finisce per disarticolare la classe e frammentare il vecchio soggetto rivoluzionario. L’ideologia della vittima, d’altra parte, porterebbe all’individualismo. Citando Lukacs, lo studioso denuncia il trascolorare della politica in prassi dell’individuo isolato, capace di produrre soltanto lotte molecolari. Quanto all’igiene comunicativa richiesta dal linguaggio inclusivo, dal momento che richiede un’ingente spesa di capitale culturale per essere praticata, incentiva una demonizzazione della classe lavoratrice.
Cangiano non è un marxista volgare, quindi riconosce i meriti di quella tradizione eretica che – da Gramsci a Stuart Hall – ha riconosciuto il ruolo delle sovrastrutture culturali, contro ogni grezzo economicismo. Insomma non vuole farla finita con lotte per i diritti civili – questa è semmai la posizione da lui definita “rosso-bruna” – bensì integrarle in una più ampia prospettiva di classe. Meno intersezionalismo e più internazionalismo. Ma è davvero realistico questo programma?
REALISMO INCLUSIVISTA
La strumentalizzazione del discorso woke in chiave antisindacale da parte di alcuni diversity manager delle multinazionali è stata ampiamente documentata. Qui come altrove, il ripiego identitario della classe lavoratrice è riuscito a spezzare la sua unità: nelle fabbriche e nei cantieri, nessuno si sente più «proletario», ma innanzitutto bianco o nero, induista o musulmano.
Prima però di accusare il wokismo di tutti i mali del mondo, bisogna ristabilire la corretta cronologia degli eventi. Non è certo la politica delle identità, formalizzata negli anni 1990 in Nord America, ad avere sferrato il colpo mortale alla lotta di classe. All’epoca questa era già un lontano ricordo: caduta assieme al muro di Berlino, resa desueta dalla deindustrializzazione e da una nuova stratificazione sociale. Quello che accade in quegli anni, semmai, è che l’identità va a riempire il vuoto lasciato dalla classe: una categoria stabile prende il posto di una ormai liquefatta. Si trattava, allora, di trovare nuove categorie politiche efficaci che permettessero di dare voce agli sfruttati e aggregare delle rivendicazioni collettive. In effetti, se applicare una netta distinzione tra borghesi e proletari – come da teoria marxiana – è diventato pressoché impossibile in un Occidente massicciamente terziarizzato, non sono invece mai state arrestate le nefaste tendenze del capitalismo alla produzione crescente di ineguaglianze. E molte di queste, innegabilmente, seguono la linea del colore.
Per questo la sintesi proposta da Cangiano, che pure convince sul piano delle idee, non costituisce un’alternativa praticabile per gli sfruttati. Oggi il marxismo non offre loro nessuna concreta prospettiva rivoluzionaria. Forse stiamo assistendo a un nuovo compromesso tra classi: dopo quello fordista tra capitale e lavoro, quello woke tra capitale e diversità culturale. Se mezzo secolo fa la promessa era la conquista del benessere, oggi ci si accontenta di un minimo di sicurezza e di riconoscimento. La logica è stringente: finché non riusciamo a pensare un’alternativa al capitalismo, tanto vale provare a “umanizzarlo” e impedire che sfoci nella barbarie. Capito perché non riesco a prendere sonno?